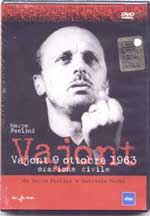Il 9 ottobre 2003 cade il quarantesimo anniversario della strage del Vajont.
Venne definita allora la maggior catastrofe mai accaduta in Italia in tempo di pace, dopo il terremoto di Messina. Ma, a differenza del terremoto, non si trattò di un'aggressione improvvisa della natura. Fu una tragedia a lungo preparata dagli uomini, il frutto di un sistema.
Questo libro ne ripercorre la genesi. E la conclusione. L'impianto, almeno in parte, rimane lo stesso del mio Morire sul Vajont - Storia di una tragedia italiana, uscito trentacinque anni fa. Ma se allora avevo voluto scrivere seguendo soprattutto i documenti, oggi parlano anche i miei ricordi di cronista, di testimone che ha seguito e vissuto l'intera vicenda del Vajont, e ne ha riportato segni che non si cancellano. Quel mio lontano lavoro era costruito essenzialmente sugli atti istruttori del processo che si sarebbe aperto all'Aquila il 25 novembre dello stesso anno, il 1968.
Gli imputati di disastro colposo di frana, di inondazione, di omicidi colposi plurimi, compiuti nella provincia di Belluno e ai confini di quella di Udine, si giudicavano nel remoto capoluogo dell'Abruzzo: per «legittima suspicione». Come accadrà qualche anno dopo per l'attentato di piazza Fontana a Milano, rinviato nella lontanissima Catanzaro. E per molti processi di mafia. Una prassi assurda, che sembrava caduta in disuso e resa difficilmente praticabile dall'ammodernamento del nostro codice penale. E ora ripristinata, e facilitata per gli imputati con maggior disponibilità di denaro e meno propensione a rispondere dei propri atti.
Quando accadde, il disastro del Vajont suscitò commozione e dolore intensissimi in tutta Italia. Ma rapidamente, come capita sovente in questo Paese che non sopporta a lungo le emozioni forti, il nome e la tragedia del Vajont finirono nella nebbia dei ricordi e, per molti, negli stagni dell'oblio. Certe vicende però incidono così nel profondo della coscienza collettiva da non risultare mai cancellate per sempre.
Quello fu il momento in cui probabilmente qualcosa ebbe a scattare nel nostro sentire collettivo, e di Vajont si ricominciò a parlare, anche fra i più giovani che nulla ne sapevano. E fu la scoperta che ben poco era cambiato in circa mezzo secolo. Come ai tempi del progetto e della costruzione della diga, si preferisce tener lontani i cittadini dalle decisioni che li riguardano, lasciarli all'oscuro dei pericoli che li minacciano, far pagare alla collettività il prezzo enorme di vite e di beni distrutti anzichè impegnarsi in scelte in cui al primo posto ci siano valori comuni invece di oscure collusioni con interessi privati.
Quel che sicuramente i decenni trascorsi hanno visto crescere è la consapevolezza sempre più vasta di quanto indispensabile sia la difesa ambientale, la resistenza più decisa contro tutto ciò che viene stabilito sopra la testa e a danno dei cittadini. Dopo i duemila morti di Longarone, abbiamo avuto la diossina di Seveso, le vittime per tumore delle fabbriche chimiche della Liguria e di Porto Marghera, il crollo del terrapieno di Stava, nel Trentino, che ha ucciso 268 persone.
I sepolti vivi dalla colata di fango a Sarno...
Per questo ritengo non inutile, a quarant'anni da quella catastrofe, tornare a scrivere del Vajont. Raccontarne, dopo la tragedia, la farsa del processo che ne è seguito. E lasciar parlare le voci che avevo custodito dentro di me per tutto questo tempo.
Mario Passi. Lago di Garda, febbraio 2003.
Appena fuori, quelle poche persone si sentono assalite dall'ansia. Anche le strade sono al buio, non c'è una sola finestra illuminata, l'intera città appare immersa nelle tenebre. Sembra d'essere tornati di colpo al tempo della guerra. In lontananza si sente come un brontolio, l'inseguirsi di tuoni. Un soffio d'aria gelida si disperde nelle strade. Il rumore cresce, è come un rombo soffocato, e sale dall'infossatura profonda che costeggia la città, dove scorre il Piave. Ora dalle case molta gente esce all'aperto, si muove verso il ponte della Vittoria che scavalca il fiume familiare, solitamente smagrito, poco più d'un filo serpeggiante fra i sassi del greto. Anche Tina Merlin si dirige sul ponte, dove già una piccola folla, dalle spallette, scruta l'acqua, altissima, che quasi sfiora le arcate. Come ha potuto crescere in pochi minuti questa piena enorme, violenta, assordante? I gorghi torbidi e veloci trascinano verso valle tronchi, sterpi, rottami d'ogni genere. Carcasse di mucche galleggiano e corrono via. La gente, atterrita, scorge anche dei corpi affiorare nella fiumana. Tanti corpi umani, cadaveri nudi spinti verso valle.
Tina osserva a lungo, scossa da un tremito, oppressa da un'angoscia terribile. Poi, di colpo, si scuote, corre in cerca di un telefono, chiama Milano, «l'Unità», il suo giornale. Le sue sono frasi smozzicate, quasi un grido spaventato: «La diga, è saltata la diga del Vajont. Ci sono morti che scendono col Piave. Tanti morti, forse centinaia...».
Aniello Coppola, il condirettore, quasi non le crede:
«Centinaia di morti, macome è possibile...». La Merlin replica esasperata: «Li vedo con i miei occhi. A Belluno c'è il terrore».
«Tina, va bene, provvediamo subito.»
 Tina Merlin, quella vera. Clicca la foto per la sua biografia. |
Da molti anni lei è corrispondente del giornale dalla provincia di Belluno. Una donna forte, decisa. Un viso un po' tartaro, naso piccolo e sottile, gli zigomi sporgenti, la figura alta e slanciata. Da ragazza, durante la Resistenza, ha fatto la staffetta partigiana. L'ultimo giorno di guerra i tedeschi in ritirata le hanno ucciso il fratello, comandante di una formazione garibaldina. Mette nel suo lavoro una enorme passione politica e civile. Lei sapeva che quella diga, da anni in costruzione sul torrente Vajont che dalla Valcellina si precipita nel Piave entro una gola stretta e altissima, costituiva una minaccia tremenda. perchè il monte Toc sovrastante il Vajont rischiava di franare nel lago profondo sotto la diga. L'aveva scritto più volte, nelle cronache venete de «l'Unità», tanto da ricavarne, nel maggio 1959, una denuncia dei carabinieri per «diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico». Processata. E assolta, dal Tribunale di Milano.
L'allarme, il turbamento, dice il Tribunale, sono veri e diffusi fra la gente della Valle Ertana, che vedono salire l'acqua nel lago e sommergere le loro terre. La giornalista ha semplicemente esercitato il diritto di cronaca.
E ora, quella sera del 9 ottobre 1963, ecco la tragica conferma.
Nell'istante in cui salta la corrente nel cinema di Belluno, si compie una immane catastrofe. È una notte sconvolgente, quella che si avanza. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, ambulanze, centinaia di macchine di volontari e di curiosi si inoltrano sulla strada che porta verso il Cadore, si dirigono a Longarone, a diciotto chilometri da Belluno, ignorando ancora che Longarone è distrutta, scomparsa.
A Ponte nelle Alpi, presso un distributore di benzina, due uomini di mezza età, scossi da una evidente agitazione, l'espressione angosciata, vengono sentiti scambiarsi frasi sconnesse: «Ma allora, è saltata la diga...»
«No, la diga no. È stata l'acqua, l'ha scavalcata. È caduta la frana...»
«Non è possibile, non avrebbe potuto uscirne tanta...».
Quei due individui smarriti, incapaci di spiegarsi ciò che sta avvenendo, sono l'ingegner Alberico Biadene, responsabile del Servizio costruzioni della SADE, accorso da Venezia, e un suo aiutante di Belluno, l'ingegner Caruso.
Da tutta Italia, intanto, si muove la macchina poderosa dell'informazione; i giornalisti partono a centinaia.
Da Milano, «l'Unità» spedisce a Belluno Piero Campisi, il suo miglior inviato di cronaca, e Sante Della Putta, che è nativo di Erto, che a Erto ha una casa quasi sul ciglio del lago. Io abito a Padova: il giornale mi sveglia prima dell'alba e mi dice di correre.
Nelle prime ore del mattino, mentre Della Puttaraggiunge la sua vallata, io e Campisi ci incontriamo con Tina, con i compagni del PCI di Belluno, con alcuni volontari dagli occhi rossi per la stanchezza, forse per il pianto. Dicono: «Longarone è sparita, non esiste più...» Mi sembra di non capire, di non capacitarmi. Da Longarone passavo ogni volta che raggiungevo il Cadore, o la valle di Zoldo, quella dei gelatai diventati famosi in tutta Europa. Ricordavo la stazione ferroviaria con il suo piccolo scalo merci, la piazza con un'antica fontana di pietra, le stradine strette fra le case costruite di massi, con i tetti di legno. E ora, tutto finito?
La tensione estrema che continua a pervadere Tina non le consente di scrivere.
Il giornale anzi le chiede di recarsi a Milano. In redazione le sue indicazioni sarebbero preziose.
Della Putta avrebbe mandato i suoi pezzi da Erto, ma dopo il primo giorno neanche lui ce la farà più.
Piero e io ci dirigiamo verso il cuore del disastro. La mattina del 10 ottobre si annuncia con un clima torbido, afoso, un sole caldo, quasi estivo. Dopo Ponte nelle Alpi, lungo la strada d'Alemagna si procede a passo d'uomo, in un ambiente da retrovia militare, in un'atmosfera soffocante inasprita dall'odore dei disinfettanti. A Fortogna non c'è più la strada. Si deve proseguire a piedi in un ammasso fangoso, superare blocchi di pietra, tronchi, pozze d'acqua, e i primi cadaveri, scomposti, abbandonati dal fiume. Mucche riverse, dal ventre rigonfio e le zampe protese in alto accentuano il senso di morte del paesaggio.
Di quando in quando mi volgo verso Campisi, in silenzio.
Anche lui mi fissa negli occhi, senza parlare.
Poco oltre Faè, dopo l'ammasso gigantesco e disperso di tronchi, di assi, di cataste sfasciate di legname dello stabilimento Faesite, ecco le prime case tagliate in due come da un enorme coltello. Poi soltanto nuda roccia sbiancata sulla quale inerpicarsi, aggrappandosi con le mani, perchè il Piave è giunto fin qui nei pochi minuti in cui si è trasformato in un apocalittico mostro. Ora il letto del fiume non ha più confini, è un immenso sterminato pianoro che incute profondo un senso d'angoscia. Scarnificato il fianco della montagna, spariti i prati e i boschetti golenali, inghiottita la strada statale. Su in alto, all'uscita dalle brevi gallerie ferroviarie, tratti di binari protesi al cielo, attorcigliati come sculture astratte. Il piccolo ponte sul torrente Maè intasato ditronchi, di brecciame. E altri cadaveri che galleggiano, poveri corpi ignudi.
Sul colle di Pirago, spogliato del suo verde, ridotto a un cocuzzolo di pietra, il relitto del campanile, rimasto solo accanto a un moncone della chiesa.
Procediamo, sempre più in affanno, sempre più intontiti, depressi, spaventati da quanto ci circonda. Ma la misura non è colma. Bisogna guardare Longarone, quel che ne resta. L'animo umano fatica a immaginare ciò che non conosce, che non appartiene in qualche modo alla sua esperienza sensibile. Io che da ragazzo avevo vissuto la guerra, i bombardamenti sulla mia città, forse inconsciamente pensavo a cumuli di rovine, case diroccate, muri sbrecciati, ammassi di macerie. Nulla di tutto questo.
Longarone appare solo una immensa distesa piatta e grigia.
Ogni casa è scomparsa, livellata, ridotta a un tritume di pietra e ghiaia. Allora, un'altra immagine si affaccia, un paragone angosciante si propone: Hiroshima, la città giapponese annientata dalla bomba atomica il 6 agosto 1945, restituitaci da poche fotografie, dalle allucinanti immagini in bianco e nero di qualche documentario.
(Apprenderemo, durante l'istruttoria processuale, che l'energia prodotta dalla massa d'acqua scaraventata sulla vallata del Piave alle 22.39 del 9 ottobre 1963 è stata pari a quella di due bombe atomiche di tipo Hiroshima, 40 mila tonnellate di tritolo).
Vediamo uomini e donne aggirarsi inebetiti sul deserto di Longarone.
Soldati avvolti in tute mimetiche, rimpiccioliti dalla lontananza, si muovono laggiù, all'estremità opposta del greto. Di quando in quando, dagli anfibi dei vigili del fuoco prendono in consegna qualcosa, il cadavere di un bambino, di un uomo, di una donna. I soldati li stendono l'uno accanto all'altro sui sassi, li coprono con un telo. Mi succede di vedere da vicino qualcuno di quei corpi tratti fuori dopo tante ore dall'acqua. Mostrano una delicata trama di vene rosse e azzurre sotto la cerea trasparenza della pelle. Non riesco a scacciare l'idea raccapricciante di agnelli scuoiati nelle macellerie. La sera prima erano persone vive, con i sogni, le speranze, le amarezze, i pensieri e i progetti di tutte le persone del mondo.
Quanti sono i morti? Dove sono? Non è possibile rispondere.
Molte vittime hanno risalito il corso del Piave verso monte, fino a Perarolo di Cadore. Altri li scopriranno via via, a decine di chilometri di distanza, verso la pianura. Nei giorni successivi, centinaia di alpini scaveranno lunghe trincee nel ghiaione spesso e compatto, per strappargli i morti che ha seppellito. Tanti bisogna cercarli nelle buche, negli anfratti, nelle pozze d'acqua lasciate dalla piena. È un lavoro duro, amaro, in cui fra gli altri vedrò impegnato con feroce determinazione il mio amico Giovanìn Bortot, sindaco di Ponte nelle Alpi.
Nelle prime ore del mattino di giovedì 10 ottobre, dopo un'intera notte trascorsa in piedi a Longarone, il procuratore della Repubblica di Belluno, Arcangelo Mandarino, fa ritorno al suo ufficio. Prende una cartellina di cartone, vi scrive sopra un numero e un'intestazione: «Atti relativi alla catastrofe del Vajont». Per prime, finiscono nella cartella le comuncazioni degli ordini di sequestro, emessi telegraficamente, di tutti i documenti attinenti alla costruzione e all'esercizio del bacino idroelettrico del Vajont. Dopo qualche ora, al ministero dei Lavori pubblici, presso il Genio civile e le Prefetture di Belluno e di Udine, nei Municipi di Erto e Casso e di Longarone, negli uffici della Società Adriatica di Elettricità - la SADE - e dell'ENEL, l'Ente elettrico nazionale da poco costituito, i carabinieri sigillano le carte che contengono la Storia e le prove dell'immensa tragedia.
Prima di sera, io e Piero torniamo in città, a scrivere e a dettare i nostri pezzi. Lui deve raccontare la catastrofe, la frana che dal monte Toc è precipitata in pochi istanti nel lago artificiale del Vajont, l'ondata di 50 milioni di metri cubi d'acqua che si è sollevata per 260 metri sull'abitato di Erto, fino a lambire il campanile di Casso, il paesino gemello, per poi rovesciarsi oltre la diga, nella stretta gola affacciata sul Piave. Come un maglio il vortice immane si è abbattuto su Castellavazzo, tagliandola in due. Ha lasciato di Longarone solo la parte più alta, poche decine di case e la metà del municipio: tutto il resto èridotto a una spianata di fango e di sassi.
Già in quelle ore si parla di duemila morti.
Io ho l'incarico di ascoltare la gente, di raccogliere le testimonianze dei superstiti. È un servizio ingrato. Mi costa uno sforzo enorme avvicinare persone sconvolte, in lacrime, ragazzi rimasti soli, mamme che hanno perduto i loro figli, vecchi che il caso ha risparmiato e rimpiangono di non essere finiti come i loro cari. La notte non mi riesce di dormire.
Faccio il giornalista da più di dodici anni, ormai. Ripenso alle esperienze più intense già vissute. Ho avuto occasione di raccontare l'arrivo della «Task force» americana a Vicenza, nel 1954, e fui messo fuori dalla Military Police durante la cerimonia d'insediamento nella caserma (italiana) «Ederle», perchè rappresentavo un «giornale comunista». Mi sono occupato di una torbida vicenda come il «processo dei pionieri di Pozzonovo», promosso dal vescovo di Padova che accusava i braccianti comunisti di un paesino agricolo di dedicarsi alla corruzione sessuale dei bambini. Gli accusati furono tutti assolti.
La vigilia di Natale del 1956 l'ho trascorsa sul monte Giner, nel Trentino, dov'era precipitato un "Dakota" pieno di gente, la prima sciagura dell'aviazione di linea in Italia. E poi il più drammatico processo antipartigiano del dopoguerra, quello «dell'oro di Dongo», dove i testimoni si chiamavano Enrico Mattei, Luigi Longo, Walter Audisio, cioè il «colonnello Valerio», giustiziere di Mussolini. Un processo rimesso a Padova per «legittima suspicione» e troncato dal suicidio di un giudice popolare, mai più celebrato.
Ma ora qui non mi sento più soltanto un cronista, per quanto impegnato.
Sto vivendo una vicenda che coinvolge, con le mie capacità professionali, il cuore, i sentimenti. Oltre la pena, l'umana solidarietà, il dolore. Per toccare la coscienza, le mie fibre più profonde, qualcosa che rimarrà per sempre.
Chi sono gli sciacalli?
L'indomani bisogna leggere i quotidiani prima di riprendere il pellegrinaggio verso la vallata dell'incubo. Le migliori penne del giornalismo nazionale intonano un concerto dal pathos straziante su immagini di morte, di dolore per le vittime e di pietà per i sopravvissuti. Nessuno come loro riesce a evocare l'atroce spettacolo sotto i nostri occhi. Ma accanto alle cronache più commoventi (Alberto Cavallari sul «Corriere della Sera»: «È l'immagine di un giorno del giudizio, surreale, come nelle pitture dell'orrido del Seicento... Hai la sensazione violenta della spietata valle di lacrime»), ecco i commenti mettere subito, pregiudizialmente, senza conoscere o misurare i fatti, le mani avanti sviolinando la tesi della «fatalità» dell'accaduto. Giorgio Bocca scrive sul «Giorno»: «Cinque paesi, migliaia di persone ieri c'erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa; nessuno poteva prevedere ..: tutto è stato fatto dalla natura che non è buona e non è cattiva, ma indifferente».Ancor più esplicito, sul «Corriere della Sera», uno scrittore bellunese, un conoscitore di quelle montagne come Dino Buzzati. Per lui la frana precipitata nel serbatoio idroelettrico del Vajont è come un sasso caduto per caso in un bicchiere pieno: l'acqua è uscita e ha bagnato la tovaglia.
Non prende in considerazione i microbi annegati da quell'acqua sulla tovaglia. Gli basta esaltarsi per il bicchiere che non si è rotto, «perchè era fatto bene, a regola d'arte... Ladiga del Vaiont era ed è un capolavoro».
E «l'Unità», che cosa deve scrivere «l'Unità» se non quel che può documentare in modo diretto? Il pericolo era conosciuto, la frana incombeva minacciosa da anni, lo avevamo pubblicato più volte, aggiunge di suo il giornale alle cronache di Piero Campisi e mie. E riproduce alcuni titoli degli articoli di Tina Merlin.
- 5 maggio 1959: «La SADE spadroneggia ma i montanari si difendono».
- 5 novembre 1960: «Una gigantesca frana precipita a Erto nel lago artificiale della SADE».
- 18 febbraio 1961: «Un'enorme massa di 50 milioni di metri cubi minaccia la vita e gli averi degli abitanti di Erto».
È il titolo più allarmante, più preciso, se non in difetto, che anticipa ciò che può accadere. E stavolta, niente più segnalazioni ai carabinieri da parte della SADE, nessuna denuncia per «diffusione di notizie false e tendenziose». Meglio lasciar cadere la notizia nel silenzio generale, tanto chi va avanti con i lavori sa già da tempo quali sono le vere misure della frana: 150-200 milioni di metri cubi almeno.
Quegli articoli non erano nati per caso, ma frutto dell'attenzione al proprio lavoro e dell'impegno di una brava corrispondente come Tina. Nascevano dalle lotte e dalla esasperazione della gente del Vajont. La SADE era arrivata dalle loro parti nel 1957 (ma li teneva d'occhio da una trentina d'anni!), quando i lavori per la costruzione della più alta diga ad arco del mondo erano iniziati ancor prima che fosse presentato il progetto definitivo. Da decenni si impadroniva dei corsi d'acqua del bellunese, espropriava vallate e terreni coltivati, sommergeva interi paesi come Vallesella di Cadore, dove d'estatein vacanza, con il lago che toccava i livelli minimi, io potevo intravedere sott'acqua il campanile e la chiesa, contare le case.
Ora toccava a Erto e Casso, i due paesini allo sbocco della Valcellina, proprio al confine fra le province di Udine e di Belluno, una piccola comunità di origine cimbra che viveva di agricoltura povera e di allevamento. Da secoli possedeva le sue «casère» sul fianco opposto della stretta vallata, sotto la cima del Toc, un ripido monte dal nome onomatopeico, a rammentare la frana preistorica da cui era nato: il nome, o forse il monte stesso. Nelle «casère» gli abitanti di Erto e Casso si trasferivano, d'estate, a falciare l'erba e a curare i campi di patate. La SADE ora toglieva loro gran parte di quei terreni, gli dava poche lire per gli espropri, e in cambio imponeva limiti e divieti. Così fra quelle poche centinaia di montanari era nato un forte movimento di protesta che aveva trovato un riferimento politico nella figura dell'onorevole Francesco Giorgio Bettiol, deputato comunista della circoscrizione di Belluno e Udine. Un uomo colto e pacato, legatissimo alla montagna e alla sua gente.
Lui aveva promosso la costituzione davanti a un notaio del 'Consorzio per la rinascita della Valle Ertana', e invitato la Merlin a seguire le assemblee dei paesani del Vajont per scriverne su «l'Unità». Così Tina si guadagnava, con l'articolo del 5 maggio 1959, denuncia e processo. Testi a difesa furono gli ertani. E il Tribunale, nell'assolvere la giornalista, scrisse in sentenza che si sarebbe dovuto vigilare sui pericoli che correva la gente di Erto. Poi sarebbero venuti una prima frana, nel novembre 1960, sinistro presagio di quanto sarebbe successo tre anni dopo su una scala immensamente e tragicamente più grande, e l'allarmante indiscrezione captata da Tina sulla «enorme massa» incombente.
Dati di fatto inoppugnabili, contro il comodo adagiarsi di commentatori illustri nella retorica della «fatalità». In ogni sciagura, dall'incidente ferroviario al crollo di un'abitazione, i mass-media si sforzano di trovare le cause, di individuare eventuali responsabilità. Di fronte alla maggior catastrofe che abbia colpito l'Italia contemporanea assumono invece il ruolo delle coefore della tragedia greca, che piangono il loro dolore programmato e invocano il fato e gli dèi. E non si chiedono altro. Sullo sfondo di un dramma umano senza confini, che scuote i sentimenti dell'intera nazione, ecco aprirsi uno scontro politico duro, una polemica perversa e avvelenata.
Quel giorno continua il penoso lavoro dei soldati e dei volontari per il recupero delle salme. In un terreno all'asciutto della frazione di Fortogna, dove alcuni campi sono ancora coperti dalle piante di granoturco, si installa una missione di medici inglesi e jugoslavi. Sono specializzati in disastri, nell'identificazione delle vittime. Ma qui di corpi, di volti resi irriconoscibili non ce ne sono molti: mancano invece i superstiti che possano riconoscere i parenti. Intere famiglie, a centinaia, sono state cancellate. I feriti risultano pochissimi. Chi è capitato sotto l'onda apocalittica che ha raschiato le rocce della gola del Vajont e cancellato Longarone non poteva salvarsi. Strappati dalle loro case, dai letti, spogliati di ciò che indossavano, trascinati via nel tumulto della piena, solo la pietosa professionalità di alcuni medici stranieri riesce ora a restituir loro almeno il nome.
Si comincia a fare la conta di chi c'è e di chi non farà più ritorno. In una stanza del municipio di Longarone, di quel po' che è rimasto, con le finestre rotte e i pavimenti dissestati, hanno approntato due registri: nel primo si allunga, ora dopo ora, la lista dei ripescati, dei defunti.
Nell'altro, il più breve elenco di chi si è salvato.
Fra le vittime ci sono il sindaco socialista del paese, Guglielmo Celso, e alcuni consiglieri comunali. Gli subentra il vicesindaco, socialista pure lui. Terenzio Arduini, si chiama.
Gestiva il bar della stazioncina ferroviaria di Longarone, cancellata. Ha perso un figlio maschio ventenne, il padre e la madre. Ha il volto scavato, gli occhi rossi di chi non dorme da due giorni, la voce rauca, quasi spenta, ma parole pacare e consapevoli. Quando arriva il presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Leone, a capo di un governo «balneare» ormai agli sgoccioli del suo mandato, Arduini loaccoglie dicendo: «Signor presidente, è stato un assassinio».
La sera, in un clima d'angoscia cui è difficile sottrarsi, convoca ciò che è rimasto del Consiglio comunale. Sono presenti anche alcuni amministratori bolognesi. Uomini che vent'anni prima avevano salito queste montagne per combattere la guerra partigiana. Hanno legami profondi con il bellunese e con il Vaiont. Sono tornati perchè si sentono solidali con questa gente. Nei giorni successivi vedrò anche Mariano Mandolesi tornato quassù dalla sua Gaeta. È un gigante bruno e ricciuto, sembra un eroe omerico. Lui fece precipitare dall'altezza impressionante del ponte del Colombèr, che univa le due sponde del Vajont, un generale tedesco dentro la sua Mercedes. E guidò l'assalto, rimasto leggendario, alle carceri di Belluno per liberare i partigiani e i politici detenuti.
Il Consiglio comunale presieduto da Terenzio Arduini formulava alcune richieste al governo e alle autorità. Prima di tutto, una rapida giustizia per le vittime e per il paese distrutto. Un miglior coordinamento degli aiuti. Misure per restituire un minimo di tranquillità ai superstiti, assicurazioni sulla fine di ogni ulteriore pericolo. Da Longarone, sopra la diga, si vedeva ormai solo il cono grigio della frana caduta che sovrastava ogni cosa. L'inquietudine, l'ansia, il timore si erano impadroniti di tutti, erano al limite di rottura. Tanto che il generale Carlo Ciglieri, comandante degli alpini accorsi da Bolzano, deciderà di dormire con i suoi uomini sotto le tende, nel desolato pianoro di fronte alla gola maledetta, proprio per rassicurare in qualche modo i sopravvissuti, mostrar loro che non c'è da temere più niente.
Gli amministratori bolognesi avevano aiutato Arduini e gli altri consiglieri, quasi annichiliti dal dramma che li colpiva, a meglio formulare le loro richieste. E questo bastava perchè si scatenassero i quotidiani del giorno dopo: «speculazione politica dei comunisti», «strumentalizzazione del dolore», e via accanendosi.
Allora, più o meno come adesso, non esistevano sfumature.
L'intero campo della «stampa d'informazione» era dominato dall'ossessione anticomunista. Ha raccontato Giampaolo Pansa nel 1993, trentennale del Vajont: «I grandi inviati dovevano descrivere. Descrivere il dolore dei superstiti. Descrivere gli alpini del Quarto Corpo d'Armata... Dovevano andare a "rompere i coglioni ai comunisti di Longarone", frase testuale, e non fatemi dire di chi è... C'era un clima ferreo, chiuso... » La DC, fece stampare e affiggere ovunque un manifesto contro il PCI intitolato «Sciacalli».

Continuavo a lavorare in preda a un profondo turbamento. Un'amarezza greve si mescolava all'indignazione e a un senso di impotenza di fronte a quello spudorato capovolgimento della verità. Gli «sciacalli» eravamo noi, non chi chiedeva l'assoluzione preventiva, chiudendo gli occhi difronte ai documenti e alle testimonianze, in nome della «fatalità». Persino Giovanni Mosca, sul confratello pomeridiano del «Corriere», il «Corriere d'informazione», respingeva tanta mistificazione e scriveva, il 12 ottobre: «Ci si rifiuta di pensare che possa esserci stato anche un minimo di colpa, che la tragedia avrebbe potuto essere evitata... Ma è un'ipotesi troppo comoda... Chi ha mancato dev'essere punito, concedere l'alibi della fatalità sarebbe vergognoso!».
Nei brevi minuti in cui l'enorme frana si mosse dal fianco del monte Toc e precipitò a una velocità di quasi 100 chilometri l'ora, scuotendo tutto all'intorno, cambiando la geografia del paesaggio, gli strumenti degli osservatòri del Veneto e del Friuli registrarono ovviamente delle onde sismiche. Ebbene, quelle onde provocate dalla frana diventarono, per alcuni giornali, un terremoto. La verità all'incontrario, un terremoto che avrebbe determinato la frana.
Cosa si voleva di più, da contrapporre alle «speculazioni comuniste»?

Io scrivevo i miei pezzi in uno stato d'animo misto di dolore per quanto testimoniavo e rabbia per la violenza ottusa scatenata contro di noi. Nel pomeriggio di sabato raccontavo un episodio cui avevo assistito a Longarone. Nel traballante ufficio del municipio entrano due ragazzi, vent'anni o poco più. Sono da poco arrivati dalla Germania. Non hanno più notizie dei loro genitori. L'impiegato presente gli mostra i due registri, gli dice di cercare lì dentro. Loro si mettono a scorrere avidamente l'elenco dei vivi, dei superstiti. Lo sfogliano due, tre volte, temono di lasciarsi sfuggire qualche nome. Noto il loro viso cambiare colore, farsi sempre più pallido. Poi, come restii, prendono in mano il registro delle vittime e, lentamente, cominciano a cercare...
Raccontavo questa scena, e di colpo dovetti lasciare la macchina da scrivere e rifugiarmi contro una finestra. Un groppo mi saliva alla gola, temevo di non poter trattenere le lacrime.
Poco dopo, mi dicono che due persone arrivate da Padova vogliono vedermi. Sono due compagni, due operai dell'ex SADE che conosco da anni. Devono consegnarmi un rotolo, un pacco di fogli ricavati da un lucido. Me li manda Lorenzo Rizzato, un ragazzo con la passione del teatro, disegnatore tecnico all'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova. Ma sul suo nome si deve mantenere la più totale riservatezza. «Vedi se questo materiale può esserti utile», dice più o meno il biglietto che accompagnava i fogli.
Utile? È la prova che la SADE conosceva tanto bene la frana del Vajont che ne aveva fatto sperimentare su modello le possibili conseguenze: per un anno intero, fra l'aprile 1961 e il marzo 1962.
 "Pochi istanti. E duemila persone morirono in una guerra che non seppero di avere combattuto". Così si conclude questo Vajont senza fine, di Mario Passi, per il quale Marco Paolini, il cantore teatrale del Vajont, ha scritto delle singolari «Istruzioni per l'uso».
"Pochi istanti. E duemila persone morirono in una guerra che non seppero di avere combattuto". Così si conclude questo Vajont senza fine, di Mario Passi, per il quale Marco Paolini, il cantore teatrale del Vajont, ha scritto delle singolari «Istruzioni per l'uso».
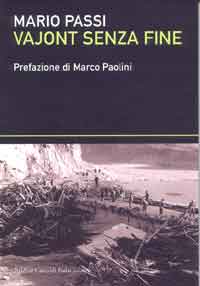 AVVERTENZE SPECIALI:
AVVERTENZE SPECIALI: