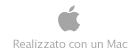|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
IL VAJONT E LE RESPONSABILITÀ DEI MANAGERPrefazione del Dr. Mario Fabbri, 
Dalla quarta di copertina: 9 ottobre 1963: una valanga di 50 milioni di metri cubi d'acqua si riversa dalla diga del Vajont sulla vallata di Longarone, causando la morte di 1.899 persone - 25 novembre 1968: dopo una fase istruttoria durata quattro anni, si apre a L'Aquila il processo contro i responsabili della strage: anche se a sedere sul banco degli imputati sono soltanto pochi tecnici, è un'intera classe dirigente a venir posta sotto accusa.ARMANDO GERVASONI, nato a Vicenza nel 1933 e tragicamente scomparso il 17 novembre 1968, giornalista professionista, iniziò a collaborare, giovanissimo, a «Il Mondo». Dal '63 era redattore de «Il Gazzettino» di Venezia.
Lire milleduecento La parte del volume qui intitolata Le responsabilità del manager ci è stata consegnata dall'Autore pochi giorni prima della sua tragica scomparsa. Viene pertanto pubblicata integralmente, senza modifiche o correzioni, nella sua prima stesura. L'EDITORE
1.A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione di "Le ombre di Erto e Casso", esaurita la prima edizione, mi sono chiesto se il libro meritasse o meno una ristampa. Gli amici mi sollecitavano. Esisteva ed esiste una certa richiesta, per cui il fatto si giustificava sul piano editoriale. Ma il discorso, per me, era un altro. E cioè: quel libro, con la sentenza di Fabbri e la requisitoria di Mandarino, con la celebrazione del processo del Vajont, non aveva, in effetti, raggiunto il suo scopo? Alcune conclusioni che in esso appaiono, non potrebbero risultare in contraddizione con i fatti successivi? E quella descrizione d'ambiente, quel rifuggire dal saggio e dal romanzo a un tempo stesso per entrare, più che nei fatti, nelle situazioni di ordine psicologico e morale dovute al disastro, situazioni fatalmente in movimento per la loro stessa natura; tutto questo non finiva con il limitare la funzione del libro a quel momento - il dicembre del 1965: due anni e due mesi dopo il disastro - esaurita e assorbita, se vogliamo, poi, dal fatto che talune ipotesi di responsabilità, formulate a quel tempo con senso di impotenza e di intima disperazione, sono state invece recepite e fatte proprie dal procuratore della Repubblica dott. Mandarino e dal giudice istruttore dott. Fabbri nelle sentenze ormai storiche che hanno portato al processo, quando oramai nessuno ci contava più? E allora? Quale significato poteva avere il riproporre un lavoro che sta a mezzo tra la saggistica e la narrativa, quando i fini per i quali esso era stato scritto s'erano per via autonoma autoimposti in misura superiore ad ogni speranza? Bisogna tornare per un momento al dicembre del 1965 per rendersi conto di alcuni perché. Era passato appena un mese dal discorso angoscioso del sindaco di Longarone Protti, in occasione del secondo anniversario. Lotteremo contro tutti, egli disse in sostanza. «Potentissime forze si muovono contro di noi, Abbiamo cercato per tutti gli Atenei e non abbiamo trovato un docente, uno solo, disposto a redigere la perizia di parte per conto del Comune. Eppure lotteremo fino in fondo, con tutte le nostre forze.» Questo diceva Protti nell'ottobre del 1965, in un'atmosfera di generale sconforto e rassegnazione. La perizia della commissione di geologi presieduta da Michele Gortani e comprendente Ardito Desio, Joos Cadisch, Bruno Gentilini, Giulio De Marchi, Carlo Morelli, Francesco Ramponi, Duilio Citrini, si era da poco espressa in senso sostanzialmente negativo nei riguardi delle maggiori ipotesi di responsabilità formulate in quell'arco di tempo, e togliendo armi alla Magistratura e in particolar modo a Mario Fabbri, giudice istruttore. A quel punto, dunque, sperare ancora nella giustizia umana sembrava una autentica follìa. "Le ombre di Erto e Casso", il libro oggi riproposto all'attenzione del lettore, è nato in questo clima psicologico e morale. Il disfacimento degli animi, oramai dimessi, della più gran parte dei superstiti e dei parenti beneficiari, il grande giro di interessi determinatosi intorno alla tragedia del Vajont, lasciavano intendere che tutto era ormai perduto e che ogni possibilità di affrontare le 'forze coalizzate' di cui parlava così esplicitamente il sindaco Protti era affidata esclusivamente all'impegno di pochi tra i non rassegnati per i quali il problema della giustizia veniva ormai a coincidere non più con la possibilità o meno di portare davanti a un'aula giudiziaria alcune persone fisiche, bensì con la ferma determinazione di trasferire al tribunale della Storia una classe politica che aveva permesso la formulazione della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta Rubinacci, sia pure con il solo voto di maggioranza, e una classe economica che ha giuocato fino all'ultimo la carta della sopraffazione.
2.In tutto questo i tecnici hanno giuocato un ruolo non da protagonisti, come sarebbe stato logico attendersi, ma da comprimari. A mano a mano che mutavano gli orientamenti, che talune impostazioni di fondo prevalevano sulle altre, i loro pareri sono sempre andati mutando, prima e dopo la catastrofe. Coincidenze, senz'altro: ma che hanno il loro peso. Contrariamente a quanto oramai si temeva, Mandarino e Fabbri ce l'hanno fatta, a prezzo di sacrifici e difficoltà inenarrabili, a rinviare a giudizio nove persone. Il processo del Vajont, pertanto, si farà. Sarà uno dei più grandi processi del dopoguerra, ed è un grandissimo risultato. Alberico Biadene, Mario Pancini, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni, Curzio Batini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin, Augusto Ghetti. Penta e Greco sono morti.1 Chi sono costoro? Biadene e Pancini sono stati i massimi responsabili tecnici della Sade prima, e dell'Enel subito dopo la nazionalizzazione. Frosini il presidente della Quarta sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, che avrebbe dovuto vigilare, è membro della commissione di collaudo, come del resto Sensidoni, ispettore generale del Genio Civile presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Batini fu invece presidente della Quarta sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici dopo Frosini. Penta e Greco: il primo, esperto e membro della commissione di collaudo; il secondo, presidente della commissione stessa. Violin, capo del Genio Civile di Belluno al tempo della catastrofe. Tonini consulente della Sade e dirigente dell'ufficio studi della medesima. Marin direttore generale della Sade, prima, dell'Enel, dopo. Ghetti direttore della facolta di ingegneria della Università di Padova e consulente della Sade. Sono tutti tecnici, dunque. Il processo del Vajont avra come protagonisti i tecnici, sul banco degli imputati. Per essi si paria di imperizia, imprudenza, negligenza, di previsione dell'evento. Non si paria di servilismo. Eppure per fare del processo del Vajont qualcosa in grado di illuminare permanentemente alcuni dolorosi aspetti della nostra storia contemporanea, sarà necessario usare molto più spesso questa parola. (1) Il 24 novembre 1968, alla vigilia del processo, l'ing. Pancini si toglierà la vita. Gli imputati restano in otto. (N.d.R.)
3.Ricordo dieci anni fa la polemica sul bradisismo nel Delta Padano per avere effettuato, a quel tempo, una serie di articoli per «Il Mondo». Ernesto Rossi, che mi è stato maestro di giornalismo, mi raccomandava: «Guardati dai tecnici che lavorano su commissione. Non perdere mai di vista per chi essi lavorano. Sono prestatori d'opera come tutti gli altri: possono dimostrare tutto e il contrario di tutto». Aveva, naturalmente, ragione, e infatti nelle sue polemiche entrate oramai nella leggenda del giornalismo italiano degli anni Cinquanta, egli ha sempre alzato il tiro al di sopra delle loro teste, spingendo sempre la sua indagine alla costante ricerca dei mandatari, dei beneficiari. Il suo bersaglio è sempre stato soprattutto il monopolio, in tutte le sue espressioni. Così i saccarieri, così gli elettrici. Da buon einaudiano egli ha sempre sostenuto che non la proprietà, ma il monopolio è un furto. La definizione dei «controllori controllati» è sua. Ricordo perfettamente una sua frase: «Gira e rigira, gli Azzeccagarbugli te li ritroverai sempre alla mensa di don Rodrigo».M'è venuta a mente quella frase quando il sindaco Protti ha messo in crisi un poco tutti con il suo discorso il 9 di ottobre del 1965: "Abbiamo girato per tutti gli Atenei e ci siamo visti chiudere le porte in faccia". No, in queste condizioni chiedere non si dice giustizia, ma almeno chiarezza sui fatti del Vajont sembrava pretesa davvero assurda. Il ricordo, infatti, era chiaro in me. Quando il Delta Padano, per i fatti alluvionali del 1960, era al centro delle attenzioni, si sono costituite subito due categorie, in fierissimo contrasto tra di loro: gli agricoltori e lavoratori della terra in genere, e i metanieri. E' necessario spendere qualche parola per spiegare la questione. Una ventina di anni fa, in tutta la fascia del Delta, ma anche nel medio e perfino nell'alto Polesine, si scopre il metano, fonte di ricchezza, naturalmente. Alcuni agricoltori diventano metanieri, altri privati costruiscono centrali con estrazione del metano in emulsione, misto ad acqua vale a dire. In un volgere breve di anni, piccole centrali di metano si moltiplicano al punto di alterare lo stesso panorama del Delta Padano. Ed il terreno comincia a sprofondare. Sembrerebbe lapalissiano. Se da quando si estrae metano si hanno alluvioni; se vi sono sprofondamenti che in talune zone raggiungono perfino quote di trentacinque centimetri all'anno, è possibile negare una correlazione tra l'estrazione del metano (e dell'acqua, soprattutto) e il costipamento del suolo? È possibile contestare che tutto questo è dovuto al prosciugamento sistematico delle falde freatiche? A posteriori, sicuramente no. Ed era infatti la tesi degli agricoltori (almeno quelli non direttamente interessati nell'estrazione del metano) i quali, nelle persone di tali Siviero e Dolfìn, sostenevano che il metano rappresentava la morte per il Delta, condannato sempre più ad essere soggetto alle alluvioni e alle mareggiate, come la storia recente dal 1951 in poi andava dimostrando. Una tesi empirica finché si vuole, ma di inequivocabile efficacia. Eppure non c'è stato un cane disposto a sostenerla. Gli agricoltori avevano ragione: ma, come direbbe il Manzoni, non sapevano il latino. I metanieri invece si sono prontamente organizzati. Il loro presidente, l'avvocato padovano Bruno Saccomani, uomo dotato di straordinarie qualità, ha creato un consorzio che era, in sè, un piccolo monopolio. Con fondi notevoli a disposizione, ha contrapposto alle teorie, giuste finché si vuole, ma approssimative, dei vari Siviero e Dolfìn (i leader del movimento antimetano), una azione coordinata ai vari livelli, che per alcuni anni ha tenuto in scacco gli agrari polesani e i loro alleati locali, per niente all'altezza della situazione nonostante che tutti gli elementi giuocassero a loro favore. Saccomani, con grande tempestività, con un piano di studio e di lavoro ha bloccato le categorie contrapposte da un lato, e gli organismi burocratici dall'altro. Protagonisti, una volta di più, di tutto ciò sono stati i tecnici: geologi, geofisici, geodeti, idraulici di profondità, idraulici di superficie. Alle parole degli agrari essi hanno, in breve, contrapposto, attraverso picchetti, sonde, rilievi piezometrici, tutta una serie di dati secondo i quali non esisteva correlazione alcuna tra il fenomeno bradisismico (che essi definivano di costipamento naturale del suolo) e l'estrazione del metano in emulsione. E non essendoci correlazione, perché mai si sarebbe dovuti intervenire contro una attività economica che dava lavoro a quel tempo a circa cinquemila addetti in tutto il territorio polesano, notoriamente considerato tra i più depressi d'ltalia? Per rendere più convincente la loro tesi hanno perfino chiamato in causa il delta del Mississippi. I vari Ponzio Pilato della situazione, vale a dire il Magistrato del Po nella persona dell'ingegner Pavanello presidente, e il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, con il suo presidente ingegner Padoan, non potendo disporre di propri mezzi tecnici e finanziari onde effettuare rilievi tali da controdedurre, per le questioni ormai arcinote e che nel caso del Vajont hanno avuto la più clamorosa delle conferme, non hanno potuto non convalidare studi effettuati da tecnici ed esperti di fama internazionale quali, tanto per non fare nomi, lo stesso professore Giorgio Dal Piaz.
4.A questo punto consentitemi di inserire brevemente nella complessa storia la mia vicenda personale, che non è brillante. Non ho ascoltato i consigli di Ernesto Rossi. Nella mia indagine ho dato credito a quella che mi sembrava la versione più qualificata, e che si fregiava dei nomi di Giarratana, Agostino Puppo, Raimondo Selli, se la memoria non mi tradisce, per non dire della lettera aulica di Giorgio Dal Piaz con la quale era bollato d'imbecillità, o giu di lì, chiunque avesse osato pensare che «togliendo una goccia d'acqua dall'oceano, questi si sarebbe abbassato», come a dire che il costipamento del Delta poteva avere mille cause, tranne quella dell'estrazione dell'acqua dalle falde freatiche. Diciamolo pure fuori di metafora: ci sono caduto come un merlo. Dimenticata per un attimo la figura mistica di Ernesto Rossi, mi sono trovato davanti, al primo piano del numero uno di Corso del Popolo, quella asciutta e tesa di Agostino Puppo, titolare - se non vado errato - di una cattedra di oceanografìa. Di fronte a molte carte con molti segni, dopo avermi fornito alcune notizie e fatto taluni raffronti, mi ha guardato intensamente e ha detto una frase che poi, proprio in occasione dei fatti del Vajont, mi è tornata alla mente una infinità di volte: «Ma lei può davvero credere che noi si voglia essere la causa dello sprofondamento di una regione?». Non l'ho creduto. Non lo credo, per la verità, nemmeno adesso. Ma l'ira di Mario Pannunzio, direttore del «Mondo», è un'altra delle cose che non dimenticherò mai. Ti sei fatto prendere per il naso, aveva tutta l'aria di dire quell'uomo alto e massiccio cui tanto deve la cultura italiana. Ernesto Rossi, poi, non mi ha nemmeno degnato di uno sguardo. Una vera doccia scozzese, poiché l'articolo (fatto davvero strabiliante per un neofita quale in effetti ero) me l'avevano pubblicato in prima pagina. Quanta ragione avevano, accidenti! E quanto mi sono dato dell'imbecille, dopo! Nell'autunno del 1960 è venuta la grande rotta di Scardovari e quella di Cà Riva, sul Po di Goro. Tutta la penisola di Cà Lattis e parte dell'Isola di Ariano, da Taglio di Po ad Ariano Polesine, sono rimaste allagate. Dopo se ne sono viste perfino di peggio, purtroppo, leggi 'novembre 1966': ma a quel tempo una simile desolazione trovava riscontro soltanto nella grande alluvione del 1951. Si è subito determinato un movimento di opinione che ha, come si suol dire, tagliato la testa al toro. Colpa o non colpa, studi o non studi, ministeri o non ministeri, le centrali di metano hanno da scomparire. Qualcuna è stata fatta saltare dalla popolazione inferocita. Poi il ministro dei Lavori Pubblici di quell'epoca, Benigno Zaccagnini, per effetto di varie pressioni, ha deciso prima in via sperimentale la chiusura di alcune di coteste centrali, quindi, in via definitiva, l'eliminazione di questa attività dal Delta Padano. La soluzione draconiana ha evitato, probabilmente, guai peggiori. Da allora il movimento bradisismico si e sostanzialmente arrestato. Il piccolo monopolio dei metanieri si è dissolto. Saccomani si è dato ad altre attività. Dei tecnici che si sono occupati della materia, almeno nella fattispecie, non si e più sentito parlare. 5.
Saltiamo dieci anni e arriviamo a qualche mese fa. Ci si trova
a Villa Condulmèr una sera d'estate con Carlo Lissandrano in un
testa a testa piuttosto impegnativo. Lissandrano è il capo della divisione 'Contratti e Lavoro' della Montecatini Edison e consociate varie: il numero tre di quell'enorme complesso dopo Valerio e Macerata. Ma ecco che il discorso a mano a mano si sposta, fino a diventare politico. Lissandrano, a quanto mi consta, se non viene dalla gavetta poco ci manca. Il monopolio diventa l'oggetto della nostra conversazione, e poiché non ho mai tralasciato d'essere un radicale convinto, non ho avuto esitazioni nel sottolineare la pericolosità che, a mio modo di vedere, è rappresentata dalle grandi concentrazioni capitalistiche 'tipo Montedison'.
Lissandrano ha seguito con molto interesse, lasciandomi parlare molto e parlando poco lui, l'evolversi della discussione. Poi mi ha preso d'incontro con una domanda abbastanza insolita, e piuttosto sconcertante. Lei, ha detto testualmente, Valerio l'ha mai conosciuto? Ho dovuto rispondere: no. Lo conosco, in effetti, soltanto per quello che si legge sui giornali.
Non è che mi sia sfuggita la pericolosità del ragionamento
sottilissimo di Carlo Lissandrano, il quale per essere un manager
e non un funzionario, è quindi abituato a impostare il ragionamento
anziché seguirlo pedissequamente, a determinare l'azione anziché subirla, s'è ben guardato dall'interpretare il ruolo dell'Azzeccagarbugli cercando la difesa del monopolio; ma s'è sforzato, piuttosto, di allontanare, anziché magnificare, l'immagine di don Rodrigo. 6.Ancora qualche episodio, se mi consentite. Sempre nell'estate del 1968 è scoppiata una violentissima crisi alla Marzotto a seguito di alcuni licenziamenti e della ristrutturazione dei cottimi. A Valdagno, antico feudo della famiglia, hanno abbattuto la statua di Vittorio Emanuele. E' crollato un mito, si è andato gridando ai quattro venti. Finalmente i valdagnesi sono liberi dalla schiavitù psicologica, oltre che economica, dei Marzotto. A quel tempo ebbi modo di scrivere un articolo che fece molto scandalo. A Valdagno, sostenevo, è caduta soltanto una statua. Il mito dei Marzotto se n'era già andato da almeno dieci anni, da quando, cioè, un sindacalista democristiano trentatreenne, Onorio Cengarle, ex operaio metallurgico, ponendo la propria candidatura in chiave anti Marzotto, aveva strappato al candidato liberale locale nella vallata dell'Agno ben diciassettemila voti di preferenza, un record in assoluto. E il candidato liberale si chiamava appunto Vittorio Emanuele Marzotto, il primo dei cinque figli del vecchio Gaetano.
Niente mito, dunque, ma una vertenza sindacale come tutte
le altre, con protagonista principale, prima ancora che i Marzotto
nelle loro persone fisiche, l'ingegner Giorgio Piantini, direttore generale, già direttore dei servizi tecnici della Lanerossi. Costui (anche se la definizione non gli piace) più ancora che un manager, è un tecnocrate. Trovatosi davanti ad una situazione di paternalismo aziendale per cui il sistema di cottimo Bedeaux (uno dei tanti figli
spurii di Frederick Winslow Taylor, l'inventore di una forma di incentivazione assai diffusa tra le Industrie tessili) era applicato in modo talmente approssimativo su di un cicio produttivo in fase di avanzata obsolescenza, da rendere perfino impossibile il calcolo del costo del lavoro; ha rivoluzionato tutto, facendo nascere, naturalmente, il pandemonio. Il discorso dunque, così concludeva il mio articolo, riguarda fino a un certo punto i Marzotto, e, semmai, uno dei Marzotto: il Giannino, che è presidente e consigliere delegato. Non molto tempo dopo il giornale mi manda ad un party nella stupenda villa palladiana di Trìssino, proprietà di Giannino Marzotto, alta su di un colle che domina la valle, e circondata da due chilometri di prato all'inglese. Dapprima ero scocciato, ma poi lo spettacolo ha cominciato a farsi interessante. Da una parte la vecchia guardia dirigenziale dei lanifìci, fatta di funzionari che hanno sempre detto soltanto sì; ed eccoli sempre così pacati, sorridenti e affabili; dall'altra Piantini (e qualche suo diretto collaboratore), anche lui minuto, fisicamente poco significante, ma dallo sguardo vivacissimo sotto le spesse lenti e dotato di grande vivacità. Me ne stavo in disparte, da solo, per questo mio singolare tipo di analisi psicologica, seguendo battute e schermaglie, quand'ecco Giannino Marzotto porgermi un Negroni e invitarmi a bere con lui. Qualche battuta di circostanza sulla bellezza del paesaggio prima di arrivare al dunque. All'articolo, vale a dire, e all'interpretazione da me data a suo tempo alla vertenza, già conclusa al momento in cui la conversazione si svolgeva. Giannino Marzotto sembrava soddisfatto a metà di quanto avevo avuto occasione di scrivere. Convinto assertore della produttività come elemento determinante di promozione socio-economica, egli ha ben capito che con i Piantini, simpatici o antipatici che siano, si va avanti, e che con gli altri si resta fermi, il che, in ultima analisi, significa andare indietro. Tuttavia, se posso usare l'espressione, m'è parso un po' geloso del suo direttore generale, e mascherando elegantemente questa forma di riprovazione, m'ha confidato che Piantini s'era un po' risentito della definizione datagli (non gli piace essere chiamato 'tecnocrate'...) e m'ha chiesto cosa mai intendevo usando l'espressione «manager». La risposta è stata molto semplice ed era lì, sotto i nostri occhi. Il manager, in senso imprenditoriale, è colui che promuove e determina l'azione prescindendo dal fatto che l'impresa gli appartenga o meno. Gli altri sono funzionari, o burocrati, servitori, espressioni passive di una volontà che si impone al di fuori delle loro personali competenze e convinzioni. Laddove vi sono dei manager, l'industria avanza: laddove vi sono padroni e servitori, l'industria (e non solo l'industria) regredisce e muore. C'è stata evidentemente coincidenza di opinioni. Il suo sguardo s'è improvvisamente acceso ed ha più volte annuito. "Se è vero quello che lei intende - ha aggiunto subito dopo - guardi che, sotto questo aspetto, lei non sta parlando con un 'padrone'. Sta parlando con un manager". 7.Un ultimo caso: la morte, piuttosto recente, di Lino Zanussi, tragica morte nel bimotore privato schiantatosi contro una montagna a San Sebastiano, in Catalogna. Quella morte è stata uno choc di incalcolabili dimensioni per la più grande industria di elettrodomestici d'Europa. Sarebbe stato logico quanto mai attendersi l'eloquio funebre, l'esaltazione delle virtù. Gli Zanussi, tutto sommato, sono la più alta espressione della nuova generazione di pionieri dell'industria veneta e nazionale e Lino Zanussi era il leader riconosciuto dell'azienda e, dunque, di questa nuova classe imprenditoriale. S'è fatto e detto molto, dunque. Ma con un tono strano. Come a dire: grande uomo, Lino Zanussi, industriale di qualità eccezionali, però attenzione. La continuità aziendale rimane, il consiglio di amministrazione si è già riunito, la perdita è stata grande ma non incolmabile, perché alla Zanussi si è sempre lavorato in equìpe e pertanto quando una funzione, sia pure la più importante, viene meno, tutte le altre suppliscono. E due giorni dopo, a funerali avvenuti, tutto è ripreso con assoluta normalità. 8.
E allora? perché questa aneddotica, questi discorsi? Perché
adesso rileggiamo attentamente i nomi degli imputati del processo
del Vajont. Fermare a questo livello il nostro giudizio, tuttavia, potrebbe essere molto pericoloso. Sappiamo tutti senza possibilità di equivoco che il processo è destinato ad esaurirsi, come massimo, al secondo grado di giudizio. Alla Cassazione non si arriverà quasi certamente, per la prescrizione. E il 1971 non è lontano. Bisogna, dunque, arrivare più in là. Se ci si dovesse fermare alla condanna platonica di otto ingegneri di serie B - ammesso che condanna ci sia - sarebbe veramente costringere il processo del Vajont entro limiti così ristretti da renderlo addirittura superfluo. Esso sarà valido e importante soltanto se il tribunale morale sarà la Storia e gli imputati un certo tipo di monopolio, di gruppo di pressione e una certa parte della classe dirigente. Per dare un minimo di efficacia a queste poche pagine, bisogna che il discorso sia svelenito, liberato da ogni incrostazione polemica, affrontato con la massima serenità d'animo. Quando l'amico Mario Fabbri ha reso pubblica la sua sentenza istruttoria, sono corso a Belluno per congratularmi con lui data l'imponenza del lavoro svolto, l'acutezza dell'indagine e, soprattutto, il coraggio dimostrato quando tutto sembrava oramai compromesso dagli esiti dell'indagine svolta dalla commissione parlamentare Rubinacci e dalla perizia effettuata dalla commissione di esperti Gortani-Desio. Non gli ho, però, confidato una mia perplessità. Che lui non potesse fare altrimenti, come magistrato, appare chiaro. Ma dal punto di vista della valutazione psicologica, ed anche politica, se vogliamo, m'era sembrato eccessivo il mandato di cattura a carico di Alberico Biadene e di Dino Tonini.
Intendiamoci: non si vuole qui dire che non meritassero questo ed altro. Ma è proprio in quell'occasione che è emersa la personalità di coloro i quali sono considerati da Fabbri i massimi responsabili del disastro del Vajont. Colpiti da mandato di cattura,
anziché affrontare con dignità la prigione in attesa di avere giustizia (qualora ritengano che questo possa e debba avvenire) hanno
preferito svicolare. Ritenuti responsabili di uno dei più grandi massacri consumati in tempo di pace, si sono comportati come ladri
di polli imboscandosi in casa di amici, dandosi alla latitanza e
impedendo, così, all'ufficiale di polizia giudiziaria di notificar loro l'ordine di arresto del magistrato. Può essere il disastro del Vajont ridotto alla stregua di tali personaggi? 9.Si è detto e ripetuto all'indomani della tragedia che Vittorio Cini, presidente e padre spirituale della Sade dopo la morte di Volpi di Misurata, avrebbe tentato il suicidio. La notizia è stata smentita ripetutamente, non fosse altro perché Vittorio Cini è un cattolico militante e per il cattolico il suicidio è cosa da non pensarsi nemmeno. Allora (sono sempre voci corse a Venezia all'indomani del 9 di ottobre 1963) avrebbe deciso di dare un miliardo ai superstiti. Amici lo avrebbero sconsigliato: così facendo significava ammettere implicitamente la propria corresponsabilità. Cini si è pertanto limitato al versamento di dieci milioni e ad altri contributi analoghi tramite le società da lui controllate. In tutto questo è il nocciolo della tragedia del Vajont, che è poi quella di una stirpe di magnati, di autocrati, di signori nel senso rinascimentale prima ancora che medioevale del termine, i quali della proprietà hanno sempre fatto un culto astratto. C'è una tale differenza di stile nelle situazioni ricorrenti a paragone di quelli che figurano imputati nel processo del Vajont, che verrebbe quasi voglia di dare ragione a Cini, che del disastro è, invece, tra i più alti responsabili. Di comprenderne, quanto meno, il modo di agire.
Per timore della sua ira, che è quella di un uomo che ha altissima la vocazione al comando, per paura perfino del suo sguardo, più lucido e penetrante di ogni ragionamento, hanno detto sì a tutto, e hanno fatto carte false per arrivare al collaudo entro i tempi tecnici previsti dalla nazionalizzazione. Non è da escludere che gli abbiano perfino nascosto fino all'ultimo la reale situazione di pericolosità per i motivi citati. Di chi la colpa di tutto ciò? Lissandrano, evidentemente, sapeva quel che diceva quando parlava della personalità dei grandi capitani d'industria contemporanei. Gli dèi di un'epoca che volge al crepuscolo, e che tuttavia sopravvive a se stessa nel fasto di talune manifestazioni quali i convegni di alta cultura della fondazione dell'isola di San Giorgio o del premio letterario 'Campiello'. Vittorio Cini è il classico Gattopardo dei tempi moderni. La sua personalità avrebbe sicuramente affascinato Tomasi di Lampedusa. La sua vita appare perfettamente divisa tra il culto della mondanità e quello dell'alta finanza. Il suo mecenatismo può avere perfino un carattere snobistico, ma è di una classe superiore. Parimenti, tuttavia, la determinazione con cui ha sempre condotto le operazioni finanziarie che lo hanno avuto come protagonista è sempre stata tale da lasciare pochissimo spazio a quelli che abbiamo definito 'manager', preferendo a questi ultimi i funzionari, quelli che dicono sempre sì. Se non fosse stato così, quasi sicuramente non si sarebbe avuta la tragedia del Vajont. Ecco perché il vero, grande responsabile è proprio lui. Sicuramente, Vittorio Cini non ha mai pensato ad ammazzare duemila e passa persone. Tuttavia, il distacco tra potere decisionale e potere esecutivo in fatto di personalità dei protagonisti, era proprio quello sottolineato in precedenza: una differenza di stile, di intelligenza, di partecipazione ai rispettivi livelli di responsabilità, tale da escludere che i Biadene e i Pancini fossero in grado di interferire minimamente sulle decisioni di massima adottate dai Cini. Solo personaggi della statura di Carlo Semenza e di Giorgio Dal Piaz avrebbero - forse - potuto. Ma quelli erano morti, e i successori non erano preparati né tecnicamente né psicologicamente a una così pesante eredità. 10.Analizziamo fino in fondo questo aspetto della vicenda se vogliamo davvero avere le idee chiare in proposito. La diga del Vajont ha avuto una genesi tra le più contrastate che si possano immaginare. Carlo Semenza e Giorgio Dal Piaz sono personaggi che potrebbero ben figurare in una tragedia greca. Nel 1937 erano già alle prese con i non indifferenti problemi che l'impervia natura del bacino del Vajont proponeva a varie riprese, e già nel 1930 s'erano avuti dubbi sulla reale consistenza dei fianchi della montagna. Scrive Semenza a Dal Piaz il 5 agosto 1937: Come Le ho detto, nella relazione occorrerebbe che Ella trattasse anche la questione della insidia solida. In proposito Ella ci ha già dato una sua preziosa relazione in data giugno 1930, di cui, a buon fine, Le allego copia e che, se Ella volesse semplificare, basterebbe oggi riprodurre in bollo. Veda Lei se Le pare il caso di lasciarla così, in forma separata, o di riprodurre la parte sostanziale della nuova. Per me la cosa è indifferente. Soltanto, per il caso che Ella riproducesse in bollo la relazione del 1930, La prego di tenere presente che a pagina cinque occorrerebbe modificare la località dello sbarramento.Questa lettera, dal vago sapore intimidatorio, è apparsa «inelegante» al giudice istruttore Fabbri, e ben a ragione. Era il tempo in cui Volpi di Misurata aveva fatto della Sade un impero personale, e il Semenza di allora, pure essendo già un tecnico di levatura internazionale, non aveva sicuramente nei confronti di Volpi, la cui personalità e ben nota in senso autocratico, e non aveva soprattutto nei confronti del sistema, il fascista, possibilità di ampia autonomia. Eppure al fondo del discorso rimangono la grande fiducia che quest'uomo ha sempre riposto nelle sue opere, l'ambizione che lo ha portato a realizzazioni sensazionali nel campo dell'ingegneria idraulica, il continuo innamorarsi della tesi per cui ciascuna delle sue creature ha sempre costituito un vero matrimonio d'amore, e la diga del Vajont forse più di tutte. Non ha mai voluto in effetti davvero credere che il bacino fosse incolmabile per difficoltà di ordine naturale. Non ha mai pensato lontanamente a rinunciare alla diga che avrebbe dovuto chiudere la carriera del più grande progettista idraulico di ogni tempo. Egli non sapeva, evidentemente, quale terribile creatura stava ideando e la sua morte, nell'ottobre del 1961, porta chiari i segni dell'amarezza, dell'avvilimento, della più profonda delle delusioni. Egli, ormai, la tragedia l'aveva intuita. La morte gli ha impedito di evitarla. S'è detto della lettera a Dal Piaz. Non è la sola in cui Semenza dà prova di temperamento e di ferma determinazione ormai al di là dei rapporti con gli amministratori della Sade e con lo stesso Vittorio Cini il quale, per la sua stessa natura d'uomo portato alla stima di ogni ingegno, è sempre stato tra i suoi più convinti ammiratori, come del resto è sempre avvenuto per Giorgio Dal Piaz. Nel 1948 il progetto di Carlo Semenza assume dimensioni di un'arditezza senza pari. Scrive nuovamente a Giorgio Dal Piaz (11 ottobre 1948): Anni fa (credo fra il 1940 e il '42) ebbi a porLe il problema della tenuta del serbatoio del Vajont verso la sella di S. Osvaldo (Val di Tuora). Ricordo che allora Ella ebbe a concludere favorevolmente. Si tratterebbe ora (in relazione a certe idee molto discutibili del resto anche da parecchi punti di vista) di esaminare la possibilità di elevare il livello del serbatoio oltre la quota attualmente prevista (677), eventualmente fin verso la 730. Alla diga penserei a prima vista che non dovrebbero sussistere dubbi sulla possibilità di aumentare la quota. Comunque gradirei anche qui il Suo parere ... Siccome mi pare di ricordare che Ella conterebbe effettuare un secondo sopralluogo nella valle, penso che potrebbe approfittarne per esaminare anche questo problema.La risposta di Dal Piaz, del 15 ottobre, fu del seguente tenore: Le confesso che i nuovi problemi prospettati mi fanno tremare le vene e i polsi.Il geologo effettuò la visita al Vajont il 20 novembre e il 24 novembre 1948 comunicò all'ing. Semenza: L'impressione d'insieme ricavata dall'esame preliminare del 20 corr. non è contraria ad un eventuale innalzamento della diga.Il 21 dicembre 1948 Dal Piaz redasse la relazione sulla struttura geologica della Valle del Vajont agli effetti degli smottamenti dei fianchi che possono derivare dal progettato invaso e dalle oscillazioni del livello del lago. Negli anni seguenti, l'ing. Semenza fece effettuare una serie di accertamenti sui fianchi e sul letto del Vajont: nel 1951-'52 vennero effettuati i sondaggi verso il Passo di S. Osvaldo per accertare il profilo della roccia, constatandosi una «non indifferente permeabilita»; nel 1953 e nel 1956 vennero condotte indagini geosismiche in zona diga e lungo i fianchi a cura del prof. Pietro Caloi e della dott. Maria Cecilia Spadea dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, mentre nel 1954 vennero effettuati e studiati cunicoli e sondaggi presso Erto. La posizione dei due grandi protagonisti della tragedia, nel 1953, è strana. Giorgio Dal Piaz riluttante e perplesso, Carlo Semenza ormai abbacinato dall'idea del «grande Vajont». Ad un certo punto, oltre ai noti Müller e Caloi, al prof. Milli di Agordo, ecco che la sorte mette Carlo Semenza contro il proprio figlio, il geologo Edoardo Semenza, che con il collega Giudici è tra i critici più accesi del progetto del padre. Egli stende alcune relazioni che irritano profondamente Carlo Semenza, e questo proprio nel momento in cui Giorgio Dal Piaz sembra convincersi via via della realizzabilità dell'impresa del grande Vajont e stende alcune relazioni sostanzialmente favorevoli. L'ira del grande ingegnere nei confronti del figlio traspare da una lettera in data 24 maggio 1960. "Riteniamo indispensabile che tu mostri preventivamente la relazione al prof. Dal Piaz, al quale preannuncio la cosa con la lettera che ti allego in copia. Se anche dovrai a seguito del colloquio attenuare qualche tua affermazione, non cascherà il mondo."Egli, dunque, considera il figlio Edoardo un intemperante, incapace di frenare gli impulsi giovanili, e capace di compromettere con una relazione di poche pagine l'opera più importante di tutta la sua vita. Ma se questo è un aspetto dell'animo di Carlo Semenza che si sente un po' tradito dal proprio figlio nel momento più difficile della carriera, e la sua lettera assume in pieno il significato del «Tu quoque, Brutus?», l'altro aspetto - quello del dubbio ormai insinuato pervicacemente in lui - lo si riscontra nella lettera che alla stessa data scrive a Giorgio Dal Piaz. "Mio figlio Edoardo ha predisposto la relazione. Gli ho detto che venga da Lei a mostrargliela. Ho piacere che Lei la veda. Anche se ci saranno eventuali sfumature di opinioni, poco male: resterebbero sempre sotto la responsabilità di mio figlio, se Ella riterrà opportuno che egli firmi la relazione."Questo, dopo aver scritto il 26 febbraio sempre a Dal Piaz: "Attendo con vivo interesse le sue osservazioni in merito. Mio figlio Edoardo, ieri, mi pareva così poco persuaso!"Edoardo Semenza, segnando una sezione della Zona della Pozza, aveva così commentato: «Comunque sia, la situazione non è brillante».
La relazione Giudici-Semenza venne presentata in giugno. Tralasceremo di trascrivere - prosegue il giudice Fabbri - ciò che concerne la serie stratigrafica e la descrizione geologica a zone, limitandoci ad osservare che per la porzione dal ponte di Casso all'imposta sinistra la relazione dice: Si tratta evidentemente di un'ampia zona rocciosa staccatasi e scivolata, per gravità, complessivamente verso NE, come è probabile data la giacitura degli strati sottostanti. La serie appare sensibilmente concorde ai due lati della valle, ma ciò è spiegabile dato che lo scivolamento in sinistra si è verificato nel Malm (almeno per quanto riguarda la maggior parte della massa scivolata). Resta dubbia l'entità del movimento, come pure l'estensione della massa che ne è stata interessata.I geologi Giudici-Semenza si occuparono quindi dei cedimenti, scrivendo: I cedimenti nel bacino del Vajont, prevedibili o già in atto, si possono raggruppare nclle seguenti categorie: frane di distacco, frane di scivolamento, frane di ammollimento e frane di tipo misto ...Egli tuttavia ha ancora forti dubbi e non li nasconde a Semenza, che in quel periodo invece è più che mai fortemente determinato a portare a compimento il grande, e non il piccolo Vajont. Scrive Dal Piaz: Ho tentato di stendere la dichiarazione per l'alto Vajont, ma Le confesso sinceramente che non m'è riuscita bene, e non mi soddisfa. Abbia la cortesia di mandarmi il testo di quella ch'Ella mi ha esposto a voce, che mi pareva molto felice. La prego inoltre di dirmi se devo mettere l'intestazione dell'Ente al quale deve essere indirizzata, e se devo mettere la data d'ora o arretrata. Appena avrò la sua edizione la farò dattilografare e Le farò l'immediato invio. Scusi il disturbo.Il giorno seguente l'ing. Carlo Semenza riscontrò la nota. Le allego copia del testo al quale Ella secondo me potrebbe in linea di massima attenersi. Ho lasciato punteggiata una frase che, se Ella crede, potrebbe mettere per illustrare le condizioni delle note cuciture fra strato e strato. L'appendice dovrebbe avere l'intestazione e la data che ho indicato sull'appunto. In ogni modo Le lascio ogni più ampia libertà. Le sono ancora vivamente grato per la Sua visita di lunedì che è stata per noi cara e preziosa.E la relazione ebbe la luce con la data del 31 gennaio e il titolo: Appendice alla relazione geologica del 25 marzo 1948 allegata al progetto della costruzione della diga sul Vajont. In seguito alla relazione in data 25 marzo 1948 sulla sezione del Vajont a valle del Ponte del Colombèr, presa in esame per la costruzione di una diga di sbarramento, la Concessionaria ha studiato una variante che comporta la sopraelevazione della quota di massimo invaso normale del serbatoio fino alla quota 722,50 (724 metri in caso di piena eccezionale) e cioè di metri 45.50 più elevata di quella prevista nel progetto del 1948.Pochi giorni dopo l'ing. Semenza tornò a scrivere al Dal Piaz: Il tempo corre ancora più velocemente dei nostri pensieri. Mentre La ringrazio ancora per aver così sollecitamente soddisfatto la mia richiesta dell'appendice alla relazione Vajont per il progetto procedurale, sta diventando di assoluta urgenza anche la presentazione del progetto per il Servizio Dighe per il quale si è pensato di preparare una nuova relazione con fotografie eec.Al progetto esecutivo fu allegata la relazione del 1948. I caratteri della diga: quota di fondazione metri 463,90; quota di coronamento metri 725,50; quota di massimo invaso metri 722,50; altezza massima metri 261,60; lunghezza del coronamento metri 190,50; spessore alla base metri 21,11; spessore alla sommità metri 5,40; volume di calcestruzzo metri cubi 355.000; corda dell'arco medio di testa metri 169,00. I lavori - citiamo ancora il giudice Fabbri - vennero iniziati senza autorizzazione di sorta nel gennaio 1957, come risulta dalla nota «urgente» al direttore generale della Sade, ing. Antonello, del 28 gennaio 1957, nella quale è scritto: Il Genio Civile di Belluno si è lamentato che, pur non essendo stato ancora presentato il nuovo progetto del grande serbatoio Vajont, se ne siano già iniziati i lavori di scavo.Attenzione a questa parte, soprattutto alla parola «contributi». In essa è la chiave che apre l'ultima delle tante porte che conducono alla conoscenza dei motivi veri che hanno portato al disastro del Vajont. Ecco dunque il Semenza che va fino al 1958. Sicuro, spregiudicato, protervo oltre che dotato di grandissimo talento e di immensa fiducia nei propri mezzi, tale da giustificare l'apprezzamento e la stima di Volpi prima, e di Cini dopo. Ma poi avvengono i disastri di Frejùs, quello più modesto ma assai più prossimo geograficamente al Vajont, di Pontesèi, tra Longarone e Forno di Zoldo. Un uomo innamoratissimo dell'opera cui stava dedicando tutto se stesso, e deciso a giungere fino in fondo, eccolo quasi all'improvviso piegarsi in sè, compreso in profonde riflessioni, non più teso a controbilanciare la decisa azione degli oppositori dell'opera, quali Müller e Caloi, ma perplesso e sgomento e, oltretutto, ferito nell'intimo per avere vagamente intuito un segno del destino nel fatto che il primo a parlare apertamente della possibilità di un disastro, laddove doveva essere la sua apoteosi di tecnico e di scienziato, fosse stato proprio suo figlio Edoardo. 11.I fatti e le situazioni interiori dei protagonisti (e del protagonista principe, soprattutto) assumono da questo momento una dimensione shakespeariana. Così si esprime il giudice istruttore Mario Fabbri, che con la sua sentenza rivela, tra l'altro, una buona disposizione letteraria nell'esposizione dei fatti. La rapida rassegna del 1959 consente di concludere che, se da una parte i tecnici della Sade potevano ritenersi soddisfatti per il progredire dei lavori, dall'altra, con l'avanzamento nella costruzione, cominciavano a vedere il profilarsi di seri e gravi problemi, come dimostra la lettera del 9 dicembre dell'ing. Semenza al prof. Dal Piaz, nella quale è scritto: «Spero di vederLa presto anche per parlare del Vajont che il disastro del Frejùs rende più che mai di acuta attualità».È ben evidente che tale catastrofe, occorsa qualche giorno avanti - il 2 dicembre - aveva non solo insinuato nella mente del costruttore seri dubbi per l'opera che stava realizzando, e della quale veniva scoprendo i difetti, ma aveva riaperto una più seria e diretta ferita, consistente nell'insuccesso tecnico occorsogli a Pontesei, dove il serbatoio della Sade sul Maè, il 22 marzo 1959, aveva dato luogo al franamento della sponda sinistra con gravi conseguenze: la morte di un uomo, Tiziani Arcangelo, e il grave danneggiamento delle opere di sbarramento. Di tale evento, che da vicino toccò la società concessionaria e il direttore del Servizio Costruzioni idrauliche, torneremo a parlare più avanti... Tutta l'opera di Carlo Semenza, nel poco tempo che gli resterà da vivere, sarà improntata alla più grande amarezza e al più profondo dolore. Si sarà notato che gran parte della sua corrispondenza era rivolta a Giorgio Dal Piaz, considerato l'«alter ego» ai fini del compimento dell'opera, oppure ai suoi critici: Müller, Caloi, il figlio Edoardo, Giudici. Agli altri, compresi i membri della commissione di collaudo, per non parlare dei funzionari del Genio Civile, egli riservava attenzioni assai limitate e comunque del tutto secondarie, appendice necessaria a un iter burocratico apportatore di noie e basta. Significativi, al riguardo, sono alcuni appunti del suo diario. Con i membri della commissione di collaudo, Dal Piaz e altri, furono effettuate visite agli impianti. Si cenò a Cortina. Il tono di Semenza, in queste note, è perfino sarcastico: "Mi sembrano tranquilli, ottimisti. Se ne accorgeranno tra sei mesi.".
Ed eccoci al 20 aprile 1961, quando i presagi di Carlo Semenza diventano tali che egli non può più tenerli racchiusi in sè
e si confida, pertanto, con il solo che sia in grado di comprenderlo
appieno: il suo maestro di Università, ing. Vincenzo Ferniani di
Bologna. Sciolgo la riserva sulla quale sono rimasto il pomeriggio del 23 marzo u.s. quando Le ho telefonato in occasione del mio passaggio per Bologna diretto in Sicilia, inviandoLe alcuni elementi circa le frane sul fianco sinistro del serbatoio del Vajont. Le allego: una planimetria scala 1/5000 sulla quale sono segnate in rosso le zone di distacco, eec.; altra tavola con alcune sezioni trasversali. Il 4 novembre dello scorso anno mentre il serbatoio era a quota ca. 650, si è staccata una frana di circa 800.000 metri cubi nella zona indicata in rosso con la dizione «frana 4.11.1960» sulla planimetria allegata, circa 500 metri a monte della diga.Questo ultimo passo della lettera è fondamentale. Dimostra che, con Semenza vivo, non ci sarebbe stato il disastro del Vajont. Il giorno seguente, Carlo Semenza completa il quadro aggiungendo: Nel rileggere la lettera che Le ho scritto ieri mi accorgo che non Le ho detto una cosa molto importante, e cioè che tutte le spie poste sul terreno e controllate da stazioni trigonometriche situate sull'altro lato della valle, negli ultimi mesi dello scorso anno hanno rilevato continui spostamenti verso valle, dell'ordine talvolta anche di qualche centimetro al giorno.L'ing. Ferniani fornì un cortese e affettuoso riscontro il 12 maggio 1961, scrivendo: Non parli di disturbo. È stato un vero piacere incontrarla. Se avrà altre occasioni di passare da Bologna, sarò lieto che mi dia simili disturbi. Le confermo che io non vedo alcuna probabilità catastrofica. Una volta fatta la galleria, che ha tempestivamente iniziato, ha già provveduto al peggio, cioè che la frana tenda ad appoggiarsi sulla sponda destra. Ma io credo che in tutto o in gran parte si adagerà su se stessa.Fatti di rilievo, stando all'istruttoria di Fabbri, nel secondo semestre del 1961, quando già la tragedia era in gestazione, furono: ... la perforazione di quattro fori piezometrici in sinistra Vajont e la ultimazione di sette fori nell'abitato di Erto; la visita della commissione di collaudo al Vajont; la morte dell'ingegner Carlo Semenza; la ripresa degli invasi; la realizzazione a Nove di Vittorio Veneto del modello idraulico che doveva portare all'incriminazione del prof. Ghetti.Morte di Semenza, uguale a ripresa degli invasi. Ecco il momento conclusivo della genesi tragica su cui sarà bene soffermarci un poco. Con rara efficacia di linguaggio, Mario Fabbri è riuscito a dare un quadro della situazione al 30 ottobre 1961, data della morte dell'ideatore della diga del Vajont. "Il 30 ottobre 1961 decedette l'ing. Carlo Semenza.
12.Dopo il 30 ottobre 1961 - prosegue nell'istruttoria il giudice Mario Fabbri - la composizione organica della società Sade non subì grosse modificazioni. L'ing. Biadene, già condirettore del Servizio costruzioni idrauliche, prese la direzione del servizio. Sul punto conviene richiamare le sue stesse dichiarazioni:Non dissimili - afferma ancora il giudice Fabbri - sono le dichiarazioni del presidente della Sade, Vittorio Cini: Per quanto riguarda il funzionamento del Servizio costruzioni idrauliche, debbo dire che tale settore godeva di ampia autonomia, anzi di massima autonomia, maggiore di quella degli altri settori. Ciò per due ragioni: l'una consistente nel complesso dei problemi tecnici che imponevano una tale autonomia; l'altra consistente nel fatto che il servizio era affidato all'ing. Semenza che per la sua personalità offriva garanzia di competenza massima. ... L'organizzazione sopradescritta non mutò dopo la morte dell'ing. Semenza, allorché l'ing. Biadene assunse la direzione del Servizio costruzioni idrauliche. Ciò fu dovuto al fatto che l'ing. Biadene, per essere stato per lungo tempo il collaboratore numero uno dell'ing. Semenza; per essere stato da questi elevato al grado di condirettore e per essere stato, in sostanza, designato quale successore nella direzione del servizio, offriva, al pari dell'ing. Semenza, ogni garanzia di competenza e capacità. 13. Parole, parole, parole. Nella realtà era come se la catastrofe fosse già avvenuta. Si noterà che per la prima volta sale sulla scena Vittorio Cini, il presidente della Sade. Prima, nella sentenza Fabbri, egli appare soltanto per esprimere il proprio entusiastico assenso alla realizzazione del grande Vajont. Ma adesso il grande vecchio parla per esaltare l'uomo scomparso e assicurare che la sezione tecnica della Sade aveva goduto sempre della più grande autonomia grazie (e soprattutto) alla straordinaria personalità del suo capo: Carlo Semenza. Dal canto suo, Alberico Biadene ha quasi l'aria di uno che si scusa. Semenza era grande, egli dice nella sostanza, ma era un accentratore. Io sono stato soltanto e sempre un secondo, più o meno con modesti ruoli, anche se sono stato fatto condirettore proprio da lui: i progetti se li è sempre fatti lui, se li è sempre realizzati, la gloria è sempre stata tutta sua ed io non sono che un povero Calibano cui è sempre stata negata ogni autentica soddisfazione. Se leggerete con attenzione tra le righe del discorso di successione, vedrete che la sostanza è proprio questa. Del resto, a questo punto, il discorso prende una piega particolare. Saranno coincidenze finché si vuole. Ma la sensazione netta che si ha, è che il peso dei tecnici in quanto tali vada gradatamente diminuendo, mentre aumenta quello degli amministratori, dei veri leader della società Adriatica di Elettricità. Giorgio Dal Piaz è lo scienziato che, pure soggetto a Semenza al tempo delle grandi idee concernenti il grande Vajont fino a dare l'impressione d'esserne il succubo, sarebbe adesso il solo, per l'età e per la straordinaria statura morale pregressa, in grado di dire no. Non va dimenticata la lettera sua del 30 luglio all'ingegner Torno che ha materialmente costruito la diga del Vajont e che per la sua parte assolutamente nulla (Torno) ha da rimproverarsi: Ognuno di noi ha bisogno soprattutto di avere la propria convinzione che a tutto è stato provvisto per eliminare le imperfezioni della Natura, dandoci l'intima tranquillità del nostro animo.Egli già aveva scritto in una relazione riservata: Come è detto nella mia relazione generale sull'impianto del Vajont, è certo che il problema di Erto è alquanto delicato e va quindi tenuto sotto continua sorveglianza.Egli, infatti, conscio della accresciuta responsabilità derivantegli dalla morte di Semenza, tenta di opporsi con la commissione di collaudo all'invaso previsto per gli ultimi mesi del 1961. Ma un incidente automobilistico lo toglierà definitivamente dalla scena proprio in quel periodo. Morirà pochi mesi dopo, nel 1962. Da quel momento scompaiono di fatto tutti i principali interlocutori di Carlo Semenza e Giorgio Dal Piaz. Müller, Caloi, Giudici, Edoardo Semenza, lo stesso prof. Raimondo Selli, il massimo tra i geologi italiani che dopo una consulenza ebbe l'impressione d'essere sgradito e si ritirò elegantemente dalla scena. Il confronto non avviene più al livello Carlo Semenza-Dal Piaz da un lato, Müller-Caloi-Edoardo Semenza-Giudici dall'altro. Avviene a livello Biadene-Violin, il capo del Genio Civile di Belluno, succeduto ad un funzionario piuttosto spregiudicato che, dopo una relazione tutt'altro che tranquillizzante, si vide subito trasferire dall'allora presidente del Magistrato alle Acque ing. Pavanello. Il Violin, in effetti, è quel personaggio che richiesto di un parere sul Vajont in quanto capo dei servizi tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici in provincia di Belluno, risponde candidamente: «A me, lo chiedete? Io il Vajont l'ho visitato solo da turista. La Sade mi passa i bollettini quindicinali e tanto mi basta». È il senso del discorso che vale, naturalmente, già riportato a suo tempo nel rapporto Bozzi.
Dal giorno dell'incidente a Giorgio Dal Piaz, 1a commissione di collaudo non s'e più riunita. ciò nonostante sono stati concessi
permessi d'invaso fino alla fatidica quota 722, la quota del «grande
Vajont», la «quota della morte». perché tanta fretta? L'autorizzazione pervenne alla società solo il 25 novembre ma, come si è visto, l'invaso era già iniziato nella seconda decade di ottobre. Il 5 dicembre la Sade (Direzione del Servizio Costruzioni Idroelettriche) inoltrò, con parere favorevole del Genio Civile, altra domanda di «invaso sperimentale limitato temporaneamente alla quota 680».Lo stesso giorno vennero inviati al Servizio Dighe i diagrammi di cui è detto nella domanda. Poiché l'autorizzazione tardava, il prof. Dino Tonini, il 20 dicembre, ritenne opportuno effettuare una visita al Ministero dei Lavori Pubblici, senza peraltro ottenere tutti i frutti sperati. Onde, il giorno seguente, invio all'ing. Sensidoni nota «riservata» che si illustra da sola: «Caro Sensidoni, sono stato leri a Roma per parlare con te e il Presidente in merito al richiesto invaso del Vajont da quota 640 a quota 680 nella speranza di poter concretare i 20 metri da 640 a 660 che mi avevi quasi promesso in occasione della mia precedente visita.L'effetto venne questa volta rapidamente raggiunto, come si deduce, tanto che l'avv. Conte (quel professionista che a Roma completava le sottili e tenaci trame intessute dal prof. Tonini del quale abbiamo già parlato) poteva scrivere: «Caro Tonini, in relazione agli accordi presi di persona nel nostro colloquio di mercoledi scorso nella segreteria del Presidente Batini, sono passato questa mattina dall'ing. Sensidoni per sollecitare l'autorizzazione all'ulteriore invaso del serbatoio del Vajont. L'ing. Sensidoni mi ha riferito di avere parlato per telefono alcuni minuti prima con l'ing. Biadene, e di avere concordato un maggiore invaso di metri venti da raggiungere con un aumento progressivo di un certo numero di centimetri per giorno. Mi ha assicurato che farà di tutto perché la lettera sia firmata in giornata di domani e sia possibilmente anche spedita.Con estrema celerità il 23 dicembre 1961 il presidente Batini firmò, come l'ing. Sensidoni aveva assicurato, l'autorizzazione che di seguito si trascrive: «Premesso che con nota 16/11/1961 ho autorizzato ad inviare il serbatoio del Vajont fino a quota 640, cioè fino al livello dell'acqua già realizzato in precedenza, nella prima fase sperimentale; considerato il soddisfacente comportamento statico della diga; che il movimento franoso permane nello stato di quiescenza, mentre il livello dell'acqua nel serbatoio è salito oltre la quota 635 e quelli delle acque sotterranee, rilevati ai piezometri, risultano sempre indipendenti dall'invaso del serbatoio, come dimostrano i corrispondenti diagrammi di osservazione aggiornati al 15/12/1961; autorizzo a titolo sperimentale la Società Adriatica di Elettricità, a parziale accoglimento della sua istanza 5/12/1961, a procedere con l'invaso fino alla quota 655 effettuando incrementi giornalieri massimi non superiori a 50 cm.».Il 27 dicembre non era ancora pervenuta alla Sade la formale autorizzazione scritta, onde venne nuovamente interessato il prof. Tonini, come risulta da una nota di appunto verosimilmente scritta da un impiegato della Sade per il suo capo ufficio: «Invaso Vajont: alle ore 10 e alle ore 16 il Genio Civile non aveva ancora ricevuto niente. Ho informato subito l'ing. Tonini il quale ha telefonato a Roma e ha saputo che la nota era ancora lì. Comunque l'ing. Tonini telefonerà lui all'ing. Biadene e l'ing. Biadene a Lei. Non aggiungo altro perché quando arriverà questa mia nota Lei sapra già tutto».L'autorizzazione scritta perverrà solo il 13 gennaio 1962 nel corso dell'invaso. Il 10 dicembre 1961 l'assistente governativo - ing. Bertolissi - redasse il suo primo rapporto informativo, che venne inviato al Servizio Dighe il 22 dicembre 1961: «Si trasmettono i diagrammi relativi agli strumenti di controllo della diga del Vajont e le osservazioni, diagrammate, dei caposaldi esistenti in sponda sinistra e dei livelli di falda rilevati in alcune sezioni lungo l'abitato di Erto (sponda destra) ed al Toc (sponda sinistra). Circa i diagrammi degli strumenti in corpo diga, essi presentano andamento regolare, rispondendo la diga elasticamente sia alle sollecitazioni termiche che a quelle del nuovo carico idrostatico.Dal rapporto dell'ufficio studi della Sade è dato conoscere la situazione a fine dicembre dell'anno 1961, al Vajont: «I punti di controllo situati nella zona del Toc non hanno rilevato nessun movimento» ...mentre «i controlli della falda freatica eseguiti nei fori piezometrici del Toc indicano che il livello delle acque sotterranee è influenzato dal livello del serbatoio soltanto nella parte più esterna della sponda dove l'incremento della quota osservata è pressappoco lo stesso di quello dell'invaso. Nella parte più interna (a circa 600 metri dalla sponda), in corrispondenza della sezione di misura 1, il livello sotterraneo sembra essere influenzato solamente dalle piogge. In corrispondenza della sezione di misura 2, l'osservazione dell'andamento della falda nell'interno della montagna non è possibile perché, come è noto, il foro piezometrico P4 è ostruito alla profondità di 40 m. I controlli della falda freatica eseguiti nei fori piezometrici nella zona di Erto, indicano che, in tale zona, l'andamento naturale della falda sotterranea non e stato disturbato dall'invaso.
|