| 
| Rapporto dall'Hiroshima del CadoreGià il giorno successivo alla catastrofe gli inviati dell'Europeo eranosul posto. A raccontare di distruzione ma soprattutto di allarmiignorati. E tragedie personali come il suicidio dell ingegner Pancini
a cura dl M. Laganà ~ L'Europeo 2006, n. 2 ~ foto dl E. Fusar
19 ottobre 1963. Alle 22.30, un pezzo di montagna frana nel lago e alza una gigantesca onda, che scavalca la diga del Vajont e si abbatte su sei paesi a valle. Sul numero dell'Europeo del 20 ottobre 1963, appaiono le prime testimonianze degli inviati, Marco Nozza e Gianfranco Moroldo:
"Questo è il rapporto su un incubo collettivo. L'incubo del Monte Toc e della diga del Vajont, prima che la vallata di Longarone diventasse la Hiroshima del Cadore. È un rapporto costruito a ritroso con argomenti riguardanti i seguenti fatti: smottamenti, crepe nelle case e nelle strade, boati nella montagna, manifesti sui muri, telefonate interrotte, proteste di comitati, lettere partite e non arrivate, denuncia da parte di un brigadiere, un processo per notizie tendenziose e false, una sentenza di assoluzione, sondaggi geologici, polemiche fra esperti...". Quattro mesi dopo, il 2 febbraio 1964, L'Europeo pubblica un servizio sui ritardi nella ricostruzione di Longarone, il paese spazzato via da 23 milioni di metri cubi d'acqua. Mino Monicelli racconta le polemiche tra il comitato dei superstiti, deciso a far rinascere Longarone dalle sue ceneri, e un vasto ventaglio di tecnici e politici, secondo i quali sarebbe più opportuno ricostruire il paese altrove, sempre sul Piave, tra Ponte nelle Alpi e Belluno. La spunta il comitato, ma questo comporta che l'avvio dei lavori slitti di almeno due anni, per ragioni di sicurezza. È impossibile aprire i cantieri, finché il bacino del Vajont non venga completamente svuotato. Il 5 dicembre 1968, L'Europeo pubblica una testimonianza postuma dell'ingegnerMario Pancini, uno dei costruttori della diga del Vajont, che si uccide a Venezia alla vigilia del processo. Nel servizio di Alberto Ongaro vengono ripercorse le ultime ore dell'uomo. Pancini ha speso gli ultimi cinque anni per dimostrare la sua innocenza, ma sente il peso di tutti quei morti. Scrive Ongaro:
"La voce che stiamo ascoltando al magnetofono è la voce di un morto. È la voce dell'ingegner Mario Pancini (nella foto, n.d.r.). È stata registrata dieci anni fa dal radiocronista Nino Vascon, nel corso di un documentario sulla costruzione della diga.
È una voce quieta, educata, sommessa, il cui tono, fra i botti delle mine che esplodono, le grida degli operai, il ronzio delle macchine perforatrici, suona quasi innaturale.
 «Avevamo l'impressione che gli scavi sarebbero stati lunghi e difficili, ma a un certo momento ci siamo trovati di fronte a rilassi diterreno, a smottamenti che inizialmente non avevamo pensato fossero possibili...Questo ci ha ritardato un pochino, ma ci ha anche condotti a rivedere il progetto che ritenevamo definitivo e a dargli piccoli ritocchi... ritocchi piccolissimi, ma che richiedono mesi di lavoro perché quando si tocca anche una sola parte di una struttura di questo genere, poi praticamente bisogna rimettere mano a tutto... Sono qui da tre anni e ci sono momenti in cui sono preso da sgomento di fronte a un'opera così grande... Abbiamo l'impressione di scatenare forze che sono più grandi di noi... quasi sembra che la natura voglia vendicarsi di quello che le stiamo facendo... Saremmo dei cattivi ingegneri se modificassimo la natura. Bacone diceva che alla natura si comanda obbedendole... Direi che questa frase esprime quello che dovremmo sempre cercare di fare... Dovremmo cioè sfruttare le forze naturali, obbedendo però a certe leggi, che sono poi le leggi della statica, senza le quali saremmo davvero dei cattiviingegneri».
Mentre il nastro gira, vengono in mente i 2mila morti del Vajont, la grandefrana che precipita nel bacino, l'immensa ondata che tracima dalla diga e che si abbatte sui cantieri, sui paesi... «Mi si chiede se gli operai hanno la sensazione di ciò che sta avvenendo... Io credo di sì. Una coesistenza in posti così isolati, di gente così diversa, non sarebbe possibile se non ci fosse un denominatore comune... penso sia proprio questo entusiasmo, questa passione per quello che stiamo facendo... ». Viene in mente l'orrore che l'ingegner Pancini deve aver provato quando, raggiunto telefonicamente in America, dove si trovava in vacanza, fu messo al corrente dell'accaduto... e le parole che disse al suo ritorno, alle mogli, ai fratelli, ai figli delle vittime: «Sono morto anch'io in quel momento. Vi giuro che in quel momento sono morto anch'io». E viene in mente la stazione di Venezia domenica mattina, e gli avvocati Artale e Ottolenghi che aspettano Pancini per andare all'Aquila dove comincia il processo, e una cucina in una casa modesta piena di gas e il corpo dell'ingegnere mezzo abbandonato sul tavolo, ormai morto d'asfissia.
«... La gente che per secoli ha continuato a fare un certo tipo di vita, un certo tipo di lavoro, nei primi anni si lamenta, e in questo senso mi pare ci debba essere da parte nostra la massima comprensione delle necessità e delle abitudini della gente del posto... », diceva nel nastro. E par di sentire il telefono che suona inviperito in una stanza vicina alla cucina piena di gas e di vedere gli avvocati Artale e Ottolenghi che si guardano l'un l'altro senza parlare e Artale che riprende il telefono per chiamare i familiari dell'ingegner Pancini e chiedergli se sanno qualcosa di lui...
Quando il nastro è finito si ha l'angosciosa impressione di aver richiamato in vita l'intero mondo travolto del Vajont... Potrebbe averle dette ieri, queste parole, Mario Pancini. Potrebbe averle scritte nella lettera di addio che invano i familiari, gli amici, gli avvocati hanno cercato di trovare. Vi si avverte un senso di malessere, una perplessità, quasi il presagio di quello che sarebbe potuto accadere... Fra tutti i dirigenti della diga, fra tutti gli imputati del processo, Pancini sembra quello che ha vissuto più profondamente la storia del Vajont.Siamo venuti a Venezia per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Mario Pancini.Venerdì sera Pancini va a trovare il suo miglior amico, un medico. L'ingegnere, che fino a un anno fa viveva con la sorella, il cognato e i nipoti, ora viveva solo. Aveva preso alloggio in un appartamento ricavato dall'abbaino di un caseggiato sopra il campo San Salvadore. La zona è centrale, ma l'appartamento è modesto. Pancini ha lasciato la casa del cognato per una ragione precisa. Non si è più ripreso dopo il disastro del Vajont e ne è consapevole. Non vuol turbare con la sua presenza la famiglia della sorella, il cognato medico, i bambini. Ha voluto andarsene lui, ma almeno una volta al giorno va a trovare la sorella, o la madre che vive in un'altra casa, non molto lontana. Era morto quel giorno d'ottobreLa sera di venerdì l'ingegner Pancini è in casa dell'amico.
Manca poco all'inizio del processo ma Mario Pancini non sembra più preoccupato del solito. Del resto il suo viso, dall'epoca del Vajont, non cambia espressione: è chiuso, cupo, il volto di un uomo che guarda al passato più che al futuro. Apparentemente, più che il processo lo preoccupa la sua sistemazione a L'Aquila, dove dovrà restare chissà fino a quando. Non è riuscito a trovare una stanza o un appartamentino in cui vivere solo. Dovrà alloggiare nello stesso albergo degli altri imputati, stare in mezzo a loro, vivere con loro anche fuori dell'aula del tribunale.
Vorrebbe evitarli?, chiede l'amico. No, non è questo, risponde Pancini, ma che senso ha che noi abitiamo al Grand Hotel mentre i sinistrati del Vajont sono costretti a dormire in tenda? Non sono nemmeno riusciti a sistemare i testimoni del processo, aggiunge. L'amico gli dice che verrà a trovarlo all'Aquila, almeno una volta alla settimana, fino alla fine del processo. Poco prima di mezzanotte Pancini se ne va. L'amico lo accompagna fino al vicino imbarcadero diSan Marcuola. Sabato, mezzogiorno. Mario Pancini pranza in casa della madre, una signora di 80 anni, cieca. Ci sono anche le sorelle e i cognati. Nessuno parla del processoche negli ultimi anni è stato un argomento quotidiano, ma il processo è nell'aria, nel silenzio che grava sulla stanza. A un certo momento la vecchia signora dice: «lo sono sicura che tutto andrà bene. Tu non hai colpa di quello che è successo». Pancini alza lo sguardo: «Colpa o non colpa» dice, «ci sono 2mila morti. Quelli restano». È una frase che ha ripetuto spesso dall'epoca del disastro, un male che si è portato addosso anche durante il lungo periodo dedicato ad analizzare la sua posizione, riempiendo pagine su pagine di osservazioni tecniche, morali, consultando esperti di tutto il mondo, magistrati, o soltanto uomini intelligenti che gli potessero dire in quale misura dovesse sentirsi colpevole uno come lui che pur appartenendo alla direzione del Vajont aveva un incarico limitato alla realizzazione della diga, che non aveva nulla a che vedere con gli invasi, nulla a che vedere con le analisi geologiche, e alle cui osservazioni sugli smottamenti gli esperti rispondevano con dati tranquillizzanti. La sua coscienza lo aveva assolto, dicono i suoi amici, ma non serviva a nulla. Ogni discorso sull'argomento si chiudeva con la solita frase senza speranza: «Colpa o non colpa, ci sono 2mila morti». Sabato pomeriggio. L'ingegner Pancini lascia la casa di sua madre e ritorna al suo appartamento. Desidera restar solo, leggere, riposare. I suoi vicini lo vedono rientrare, salire le scale lentamente. Verso le tre e mezzo riceve la visita dell'avvocato Artale, che assieme agli avvocati Ottolenghi e DeMarsico compone il collegio di difesa. Siedono nel tinello. Non sono un avvocato e un cliente, ma due amici. Parlano del processo, del memoriale di 150 cartelle che l'ingegnere ha scritto per aiutare il lavoro dei suoi difensori. Sul frontespizio del memoriale non ha scritto "ingegner Mario Pancini", ma "imputato Mario Pancini': anzi ha scritto "imp." così come si scrive "ing." o"dott.". Quell'«imp.», diceva, era l'unica qualifica rimastagli.
Verso sera suonano alla porta. È uno dei cognati di Pancini. È venuto a prenderlo, vuole che Pancini faccia quattro passi. I tre uomini escono assieme. L'avvocato Artale abita al Lido e Pancini e il cognato lo accompagnano al vaporetto. Prima di lasciarsi si mettono d'accordo sull'ora in cui si incontreranno alla stazione. «Allora», dice l'avvocato, «domani mattina alle nove e mezzo». «D'accordo», risponde l'ingegnere: «alle nove e mezzo». Domenica: ore nove e mezzo. Gli avvocati Artale e Ottolenghi sono alla stazione e aspettano il cliente. Ma l'ingegnere non si vede. Passano dieci minuti al termine dei quali l'avvocato Artale decide di telefonargli a casa. Nessuna risposta. Passano altri dieci minuti e Pancini non si vede. Se tarda ancora un poco perderanno il treno. I due avvocati decidono di dividersi. Ottolenghipartirà per L'Aquila, Artale aspetterà ancora e cercherà di sapere che cosa è accaduto. Sono in ansia, ma ieri Pancini sembrava tranquillo o quanto meno non più turbato del solito. Del resto sanno tutti e due che dell'esito del processo gliene importa poco: la sua coscienza ha già stabilito che "colpa o non colpa, ci sono 2mila morti". La scelta di farla finitaOttolenghi parte, Artale riprende in mano il telefono. Chiama la casa di Pancini, ma si sente il solito squillo a vuoto; chiama allora una delle sorelle di Pancini: lei dice che andrà immediatamente a casa del fratello e prega l'avvocato di raggiungerla. Insieme con una cognata la signora corre alcampo San Salvadore, apre la porta dell'appartamento. Grida il nome del fratello. A prima vista l'appartamento è deserto; ma in camera da letto, sistemati su una sedia, vi sono i vestiti che l'ingegnere avrebbedovuto indossare per il viaggio. Le due donne corrono in cucina: la porta è chiusa dall'interno. L'unica speranza è che non sia troppo tardi. Le due signore tentano in tutti i modi di abbattere la porta, ma vi riescono solo pochi minuti dopo, quando irrompono nell'appartamento Artale e il cognato medico. Dalla cucina viene un forte odore di gas. Le finestre sono chiuse, tappate, ma nella penombra si vede il corpo dell'ingegner Mario Pancini seduto e con il busto abbandonato sul tavolo. Il medico e Artale trascinano il corpo inerte fuori della cucina, mentre le duedonne spalancano le finestre, bloccate con lo scotch. Anche le fessure laterali della porta sono bloccate, come pure il buco della serratura. L'ingegnere ha pensato a tutto. Ma il suo corpo sembra ancora caldo.
Il cognato medico pratica la respirazione bocca a bocca, Artale chiama la Croceazzurra. Ma è troppo tardi. Ora tutti si chiedono perché Mario Pancini si sia ucciso alla vigilia del processo. Tutti si chiedono che cosa possa averlo fermato dopo che aveva già preparato la valigia, si era fatto la barba e aveva disposto su una sedia i vestiti da indossare. Le stesse domande se le pone chi vede in Mario Pancini uno dei responsabili del disastro del Vajont e anche chi lo considera innocente e lo ricorda con affetto. Nell'ondata di sgomento che ha seguito il suo suicidio abbiamo voluto sentire la voce di qualcuno che lo abbia conosciuto da vicino e che sia stato coinvolto nella sciagura. Abbiamo parlalo con una donna e un uomo di Tai di Cadore: Cesarina Coletti e Adone Rossi. La prima ha perso il marito sotto la valanga d'acqua piombata dalla diga, il secondo ha perso il fratello. «Mario Pancini era una persona cui non si poteva non voler bene», dice Cesarina Coletti. «Non l'ho mai considerato responsabile di nulla e ho provato sorpresa e dolore quando ho saputo di che cosa lo accusavano. Ora che si è ucciso, lo piango come se avessi perduto qualche cosa che mi era cara, una persona che mio marito aveva amato e stimato. C'è chi lo accusa di essere uno dei diretti responsabili della tragedia, c'è chi lo accusa di non aver parlato con i suoi capi, di non aver detto che la situazione era pericolosa e di non aver ordinato lo sgombero. Ma a parte il fatto che spettava ad altri e non a lui di ordinare lo sgombero, tutti sapevamo che la situazione era pericolosa, lo sapeva anche mio marito che era uno dei tecnici del gruppo diretto da Pancini, lo sapevo anch'io. Eppure nessuno è salito sul Monte Toc per gridare alla gente della valle di andarsene. Nessuno se n'è andato. Allora sono colpevole anch'io, e anche mio marito è colpevole e sono colpevoli tutti quelli che sono rimasti. Ma dirò di più. Sono convinta che se l'ingegner Pancini fosse stato qui nei giorni che hanno preceduto la frana avrebbe preso una iniziativa, avrebbe dettoalla gente "chi vuol andarsene se ne vada, io resto ma chi vuol andarsene se ne vada".
Dopo la morte di mio marito ho ricevuto dall'ingegner Pancini una lettera in cui mi diceva che era morto anche lui, che la sua vita era finita, che anche lui era stato travolto dalle acque. Io non so come abbia vissuto in questi anni. Ma posso immaginare che la sua vita sia stata un inferno. Credo anche che del processo gli importasse ben poco. Anche se lo avessero assolto, il suodramma personale non sarebbe finito».«Non doveva uccidersi», dice Adone Rossi, fratello del geometra Bruno Rossi. «Non toccava a lui finire in quel modo. Io l'ho visto quattro o cinque giorni dopo il disastro, era già un uomo distrutto. Perché siè ucciso? Che cosa poteva fare lui per evitare il disastro? Era in America in quel periodo, e prima non poteva far nulla perché c'erano le perizie geologiche che non sembravano affatto allarmanti». Ma, durante la costruzione della diga, l'ingegner Mario Pancini doveva provareun senso di allarme, di fronte agli smottamenti del terreno, anche se le perizie dicevano che non era il caso di allarmarsi. Lo dimostrano anche le parole registrate dieci anni fa e conservate nel nastro del magnetofono. Forse Pancini si è chiesto se il suo torto non sia stato prendere troppo sul serio analisi che la realtà sembrava smentire. «Il guaio dei tecnici» ebbe a dire una volta a un amico, «è che si fidano troppo della tecnica. Un po' di dubbio gli farebbe bene. Un dubbio filosofico, un dubbio morale».
Forse nella coscienza di Mario Pancini si è fatto strada in questi anni un nuovo modo di vedere le cose, secondo cui un tecnico non è solo un esecutore di ordini, ma un uomo che può rifiutarsi di far qualcosa, se non ne è convinto fino in fondo. In questa luce, il suo suicidio assume un profondo significato morale".Fin qui Ongaro.
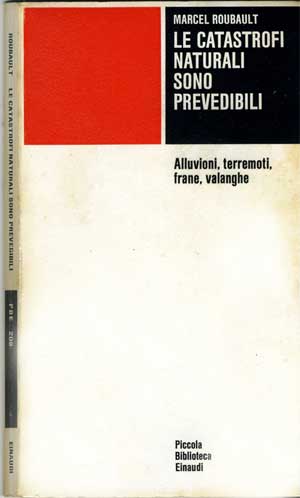
Clicca l'immagine per leggerlo |
L'Europeo torna sul Vajont il 25 ottobre 1973, con un'intervista esclusiva di Corrado Incerti al docente di geologia Floriano Calvino, dell'Università di Genova e perito del tribunale per la catastrofe. Le sue parole crude e coraggiose gettano una luce sinistra sulla tragedia.
«Il Vajont», dice il professor Calvino, «non ha mai avuto giustizia. Tutte le calamità cosiddette naturali sono prevedibili, e quella era più che prevedibile, era addirittura certa».Dieci anni dopo, qual è la verità? La frana del Monte Toc era stata la piùseguita e studiata fra quelle conosciute e nessuno fece nulla, non dico per fermarla,forse era impossibile, ma per impedirne icatastrofici effetti. Non sto ora a enumerarei vari segnali di allarme, ricevuti dopo la costruzione della diga (anche il figlio del costruttore Semenza aveva segnalato in passato il pericolo), ma da tre anni prima della catastrofeerano stati disposti sulle pendici del Toc deipunti fissi e gli spostamenti della montagnaerano continuamente misurati. Sulla basedei diagrammi di spostamento, orizzontalie verticali, nessuno dei responsabili avevasaputo, in tre anni, tirar fuori nulla di preciso. Anzi, i periti pessimisti venivano scartati. Solo un geologo, il professor Penta, erarimasto a sorvegliare la frana. La sorvegliava da Roma. Se si fosse preso la briga di correlare i movimenti registrati dai segnali,avrebbe visto che delle due ipotesi fatte, frana 'superficiale' o frana 'profonda', la prima doveva per forza essere scartata. È questa la verità tecnica del Vajont? Certo. Era chiaro, lo doveva essere datempo, che i punti posti lungo le pendici delToc non si muovevano 'lungo' il versante,ma si muovevano 'in fuori': non era quindiun tappeto superficiale a scivolare, ma doveva esistere una superficie di scorrimento profonda.
In parole meno tecniche, il Tocminacciava non di 'scivolare' nel bacino delVajont, ma di precipitarvi. Come accadde. Sondaggi profondi furono mai fatti? Una volta. Arrivarono fino a 200 metri di profondità per piantare tubi di ferro, i "piezometri". Anche il fatto che quei tubi non siano mai stati tranciati dalla frana, che pure aveva fatto ben 4 metri di strada prima di slanciarsi, dimostrava che era tutta la montagna a muoversi per almeno 200 metri di profondità. I diagrammi degli spostamenti, da noi presentati al tribunale dell'Aquila, mostravano una velocità crescente, segno che la catastrofe stava avvicinandosi. A saper leggere, e a volerli leggere, i dati tecnici, si doveva conoscere anche la data della caduta del Monte Toc nel bacino del Vajont! Ma ci furono relazioni tecniche... Il quindicesimo rapporto dell'austriaco professor Müller, in data 3 febbraio 1961, parla di 200 milioni di metri cubi di massa franosa, di accelerazione della frana a ogniriempimento del bacino e parla di rischio per la diga se la frana fosse scivolata "di colpo". Dopo quella perizia, il professor Muller continuò a lavorare per la Sade, ma non per la frana: lo si incaricò solo di questioni marginali, quali il consolidamento delle spalle della diga.
Cioè, dopo che aveva dato cattive notizie ai proprietari dell'invaso, questi non l'hanno più interpellato. Ci fu a Padova una prova su modello.  La diresse il professor Ghetti. Ma nessuno dei responsabili lo mise mai al corrente della reale situazione geologica della zona. Fatto sta che il suo esperimento non prospettò il pericolo reale. In pratica, per la limitata velocità con cui si fece cadere la ghiaia nel bacino-modello. Nessuno, in quel momento, gli prospettò la possibilità della caduta di colpo della montagna nel lago, perché nessuno dei responsabili, ripeto, aveva saputo, o voluto, leggere correttamente i dati delle rilevazioni sul monte. La diresse il professor Ghetti. Ma nessuno dei responsabili lo mise mai al corrente della reale situazione geologica della zona. Fatto sta che il suo esperimento non prospettò il pericolo reale. In pratica, per la limitata velocità con cui si fece cadere la ghiaia nel bacino-modello. Nessuno, in quel momento, gli prospettò la possibilità della caduta di colpo della montagna nel lago, perché nessuno dei responsabili, ripeto, aveva saputo, o voluto, leggere correttamente i dati delle rilevazioni sul monte.
Imperizia e negligenza hanno dunque ucciso le 2mila persone di Longarone. Sono queste le sole cause? Altri motivi: disprezzo della vita umana, e questo fa parte del costume della nostrasocietà; sete di profitto, e questo tocca gli interessi formidabili che stavano alla base dell'utilizzazione di quel bacino; corruzione, e questo è il momento dell'incontro fra quegli interessi e il potere pubblico che dovrebbe controllarli e che invece, in questo contesto politico e sociale, con essi si adagia. E aggiungo: il presagio dell'impunità. Vale a dire? Una prova generale del disastro del Vajont c'era già stata, non su modello, manella realtà. Nessuno fu mai perseguito. È sempre stata la regola. Nel 1959, a pochi chilometri dal Vajont, una frana era caduta di colpo nel bacino di Pontesei, sempre della Sade. Per puro caso morì una sola persona. Pochi minuti prima era stata bloccata una corriera carica di viaggiatori: si ritrovarono con l'acqua alla gola ma sopravvissero. Quella frana aveva le stesse caratteristiche di quella del Vajont. Al processo dell'Aquila feci un parallelo fra volumi, velocità e altezza dell'onda e ne uscì una proporzione (unapossibilità di previsione per il Vajont) abbastanza fedele. A Pontesei, l'ondata passò per 20 metri la cresta della diga e si propagò anche a monte sbriciolando un ponte e investendo la corriera. Non ci fu alcun processo allora, e nessuna inchiesta. Solo un rapporto dei carabinieri, e subito archiviato. Perché, con tante prove, le condanne per il Vajont furono così miti? Perché il tribunale di primo grado si pronunciò per l'imprevedibilità della catastrofe? Entriamo nel cuore del problema. Nell'ottobre del 1963 io ero a Padova, come professoreincaricato di geologia in quella Università, e la risonanza della frana, negli ambienti accademici, fu enorme. Le facoltà scientifiche e tecniche erano, chi più chi meno, vere succursali della Sade, Società adriatica di elettricità. Diversi cattedratici avevano messo il nome, il personale e i laboratori al servizio dell'azienda monopolistica, certe nomine universitarie erano decise sul Canal Grande, nella sede della società. Ma, all'epoca del disastro, la Sade era già stata nazionalizzata. Da qualche mese. Ma poco importava: quasi tutti gli uomini del conte Cini erano rimasti al loro posto nella neonata Enel. Dunque, i baroni patavini furono presi dalla paura, un sentimento che scomparve alla nomina del collegio dei periti: gente fidata, così noti agli elettrici che uno di essi era stato persino interpellato in gran segreto dalla stessa Sade, un paio d'anni prima, proprio per la frana del Vajont!
Dopo 18 mesi ne vien fuori una perizia che sanziona di fatto l'imprevedibilità dell'evento, una perizia così poco apprezzata dal giudice istruttore che, fatto nuovo nella giurisprudenza, questi nomina un nuovo collegio di periti, affinché diano garanzia di indipendenza. C'erano già state altre "assoluzioni"? La commissione ministeriale aveva parlato di una misteriosa "discrasìa", rottura di un equilibrio, e quella parlamentare d'inchiesta, il cui presidente divenne più tardi ministro per la Ricerca scientifica, aveva stabilito l'imprevedibilità della catastrofe. Dunque, nel nuovo collegio peritale c'è anche lei, unico italiano. Il giudice si ricordò di un professorino di Padova che gli aveva rilasciato una perizia, da lui giudicata obiettiva, sullo schiacciamento di un operaio in una cava vicino a Belluno, e mi affiancò a tre grandi nomi della scienza, i professori Roubault e Gridel, francesi, e il professor Stucky, svizzero, già Rettore del Politecnico di Losanna, progettista di 50 grandi dighe in tutto il morődo. Sciagura prevedibile, secondo voi. Noi sostenemmo che la verità sul Vajont era già scritta nei diagrammi. Il professor Roubault elencò analoghi fenomeni precedenti (quello svizzero di Goldau e un'ondata di 510 metri provocata, cinque anni prima del Vajont, da una frana a Lituya in Alaska); il professor Stucky sostenne che non si sarebbe mai dovuto far salire il livello del lago in un modo così sconsiderato. Fummo categorici.
Nella perizia scrivemmo: "Si sarebbe dovuto rinunciare per un certo numero di anni all'esercizio del serbatoio". Si doveva, cioè, usarlo solo come acqua fluente fino alla caduta certa della frana. La perizia non fu molto considerata... 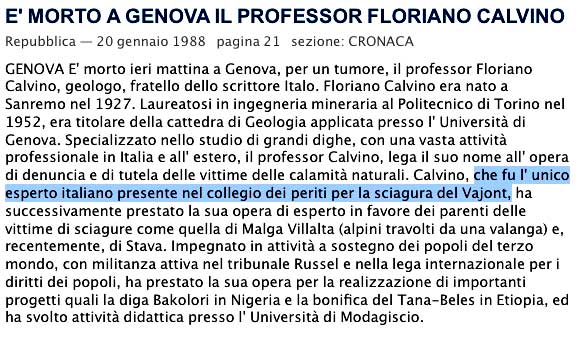 Per il processo si scelse una sede lontana e asettica, L'Aquila, e un presidente già allora chiacchierato e in questi giorni sotto inchiesta per brogli di miliardi, mentre da una parte si ergevano difensori di grido e dall'altra stava una parte civile disunita e guidata in maniera dubbia. Il risultato fu che noi del secondo collegio fummo sottoposti a un trattamento speciale: ci fecero andare per primi e ci tennero per quattro o cinque giorni sotto il fuoco di fila delle domande dei difensori. Poi, via via, interrogarono per mesi tutti gli altri. Chiaro che l'effetto delle nostre relazioni era sminuito. Per il processo si scelse una sede lontana e asettica, L'Aquila, e un presidente già allora chiacchierato e in questi giorni sotto inchiesta per brogli di miliardi, mentre da una parte si ergevano difensori di grido e dall'altra stava una parte civile disunita e guidata in maniera dubbia. Il risultato fu che noi del secondo collegio fummo sottoposti a un trattamento speciale: ci fecero andare per primi e ci tennero per quattro o cinque giorni sotto il fuoco di fila delle domande dei difensori. Poi, via via, interrogarono per mesi tutti gli altri. Chiaro che l'effetto delle nostre relazioni era sminuito.
Il tribunale di primo grado sanzionò che l'evento era imprevedibile. Solo in appello si riconobbe la prevedibilità della catastrofe ma l'entità delle condanne non fu sostanzialmente modificata. E uno dei condannati, l'ingegner Francesco Sensidoni, il direttore del servizio dighe del Ministero cui in appello diedero quattro anni e mezzo di reclusione, non vide in pratica mai l'interno di un carcere.
Oggi, comunque, a tre anni dalla sentenza d'appello, tutti i responsabili sono liberi.
Il nodo centrale è la responsabilità di fronte a catastrofi di questo tipo. Dieci anni dopo il Vajont, come è la situazione? Peggiore. Già la legge diluisce molto le responsabilità, ma dopo il Vajont chi ha qualche responsabilità, ogni volta che ha il presagio del disastro, cerca immediatamente di scaricarla, inviando raccomandate con ricevute di ritorno a destra e a sinistra per inguaiare gli altri. Non esiste una responsabilità dei controllori pubblici, come il Genio Civile? Ce n'era poca prima, ce n'è di meno oggi, dopo che la nuova normativa per i burocrati ha tolto loro quasi ogni responsabilità. Ma almeno, ora, si fa qualcosa per prevenire le catastrofi?
Il Vajont ha insegnato qualcosa? Direi di no. In Italia ci sono 3mila frane in atto, parlo solo di quelle denunciate, che interessano lo 0,5 per cento della superficienazionale, ben 150mila ettari. Abbiamo il primato europeo della franosità. Ma non esistono controlli organici, solo qualche iniziativa qua e là. Che cosa si potrebbe fare? Ci vogliono studi, controlli organici, e invece i geologi addetti dallo Stato all'intero settore della geologia applicata si contano sulle dita di una mano. Bisogna poi che al rilevamento della carta geologica d'ltalia, che è durato cento anni, si aggiunga il rilevamento di carte geologiche specifiche, carta delle frane, carta delle zone sismiche, e così via. Tutte cose che mancano. Il problema non sono solo le frane... Per le alluvioni, e si vede ogni anno, esiste un sistema di controlli antiquato, che va dal messo in bicicletta al telefono. Ma, si sa, se si rompe l'argine, saltano anche le linee telefoniche! Manca un sistema centralizzato, osservatori collegati da stazioni radio, un centro di elaborazione con calcolatore elettronico. Un sistema già in atto con successo in Francia, nel bacino della Dordogna.
Poi ci sono i terremoti. Abbiamo una legge antisismica, che impone certi obblighi di costruzione. Ma il loro numero è insufficiente, tant'è che nove volte su dieci un terremoto distruttivo, in Italia, va a colpire un comune che è fuori elenco. Anche qui ci si scontra con interessi ben precisi. Pensi cosa succederebbe se si dovesse dichiarare, come sarebbe giusto, tutta la Riviera ligure di Ponente zona sismica! E quando un terremoto in quella zona abbatterà le case, cosa si dirà? Che è stata una catastrofe naturale? Certo, i responsabili non si troveranno. Che accade a chi, come lei, si pone contro i baroni e gli interessi economici, achi si comporta da cittadino libero? A chi denuncia gli aspetti di criminalità organizzata dell'establishment, si può anche aggiungere...
Dopo blandizie, pressioni e minacce in corso di perizia, ho dovuto lasciare l'Università di Padova e sopportare due bocciature a concorsi, prima di riuscire a vincerne uno. Non è un invito a credere, è la verità.
L'invito è invece a lottare per impedire le perizie addomesticate, i veli diomertà; per impedire che le alluvioni siano considerate catastrofi naturali, per costruire un modo di vivere a misura d'uomini.

| | 
|  | 
|
|